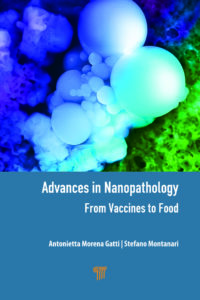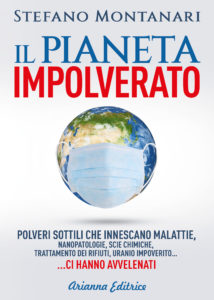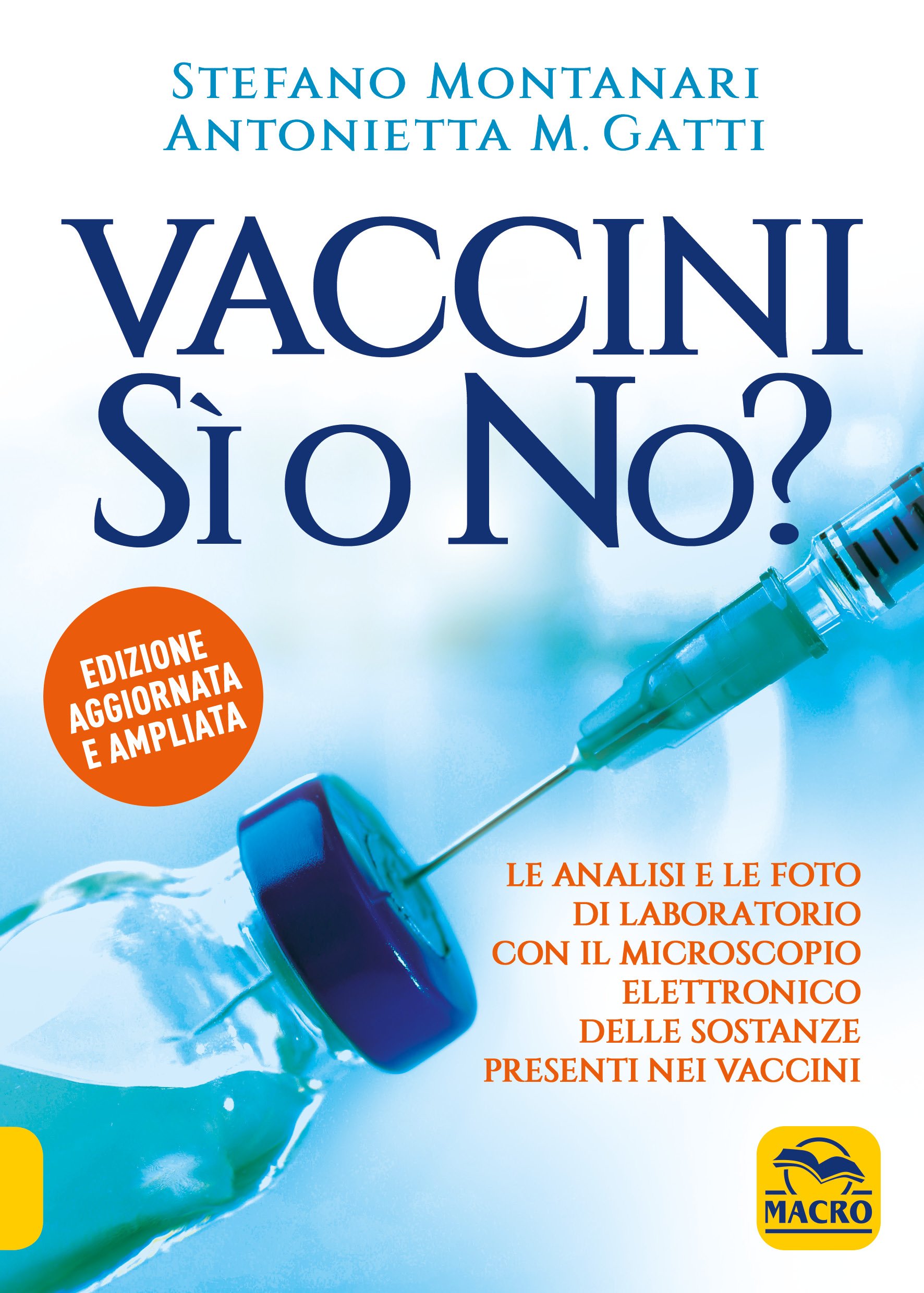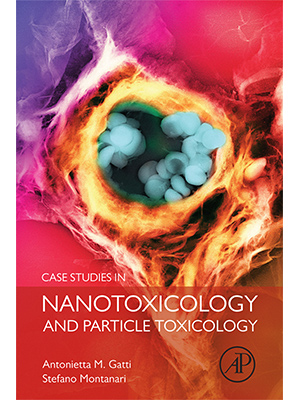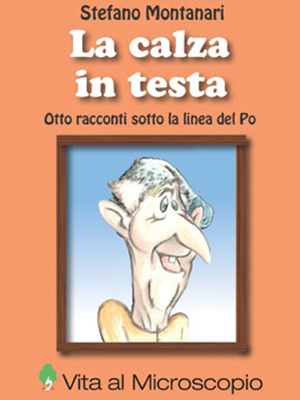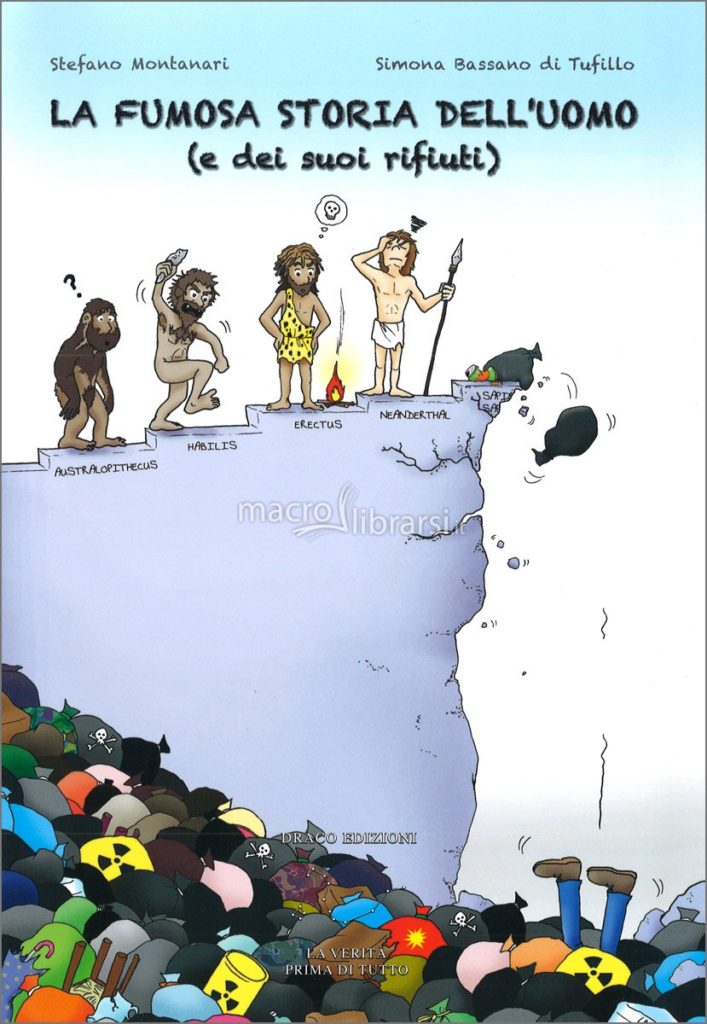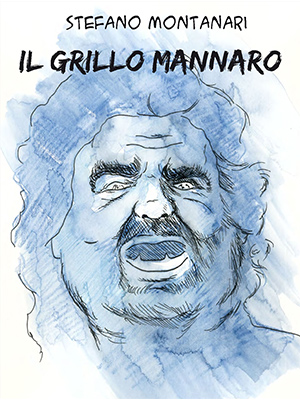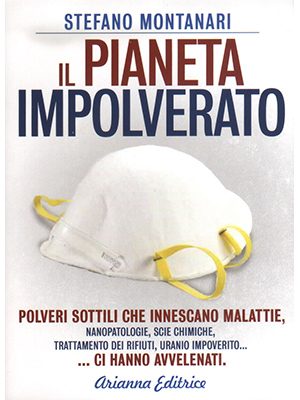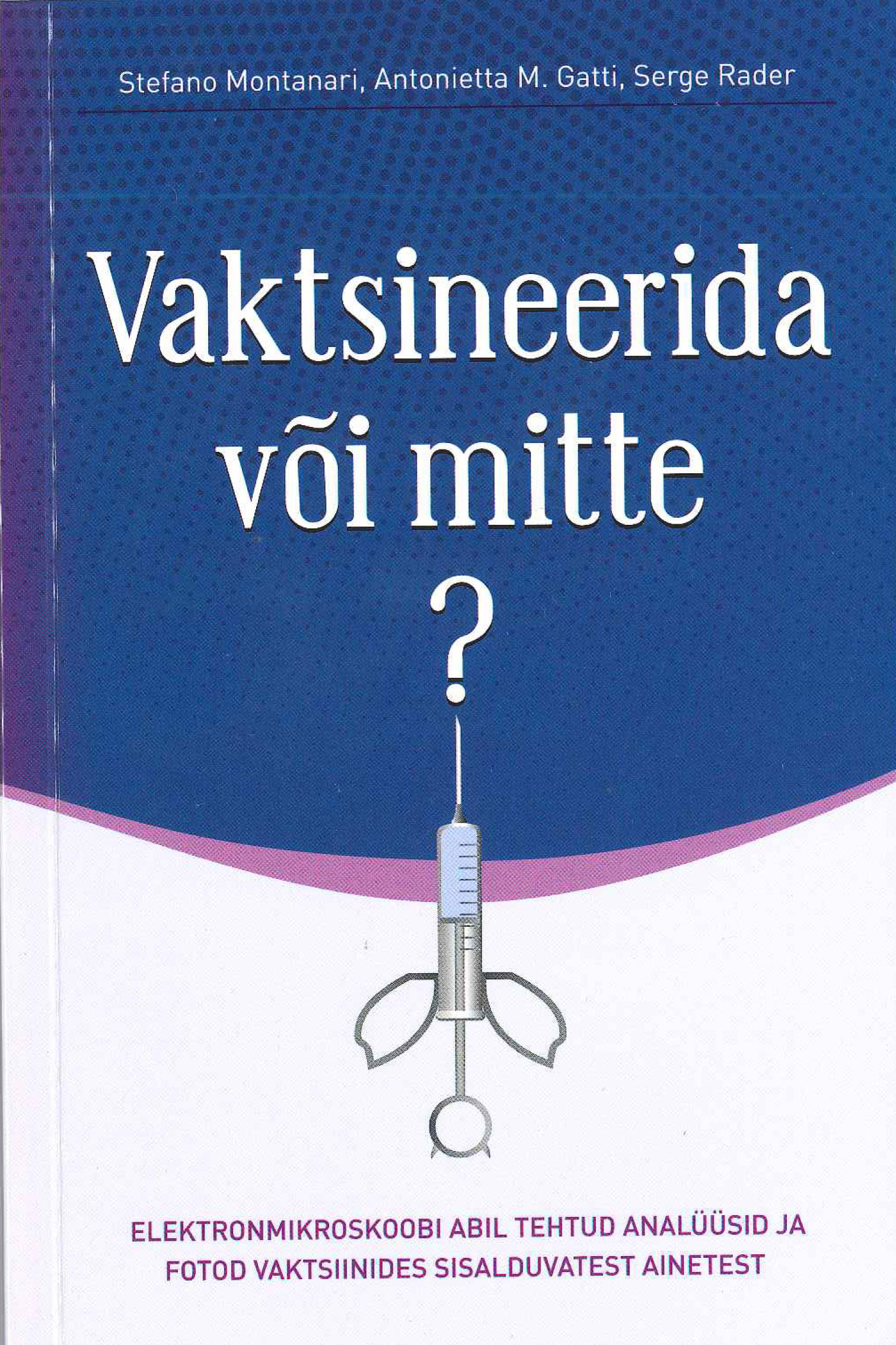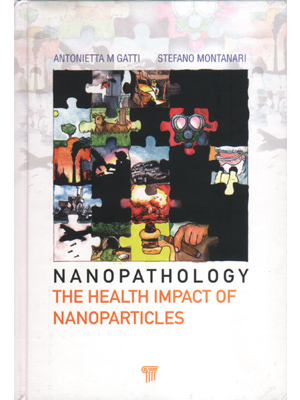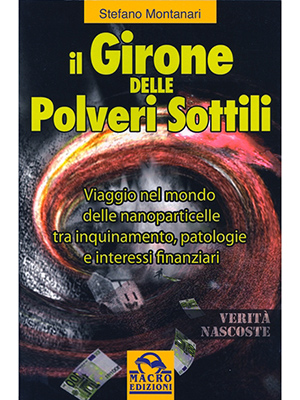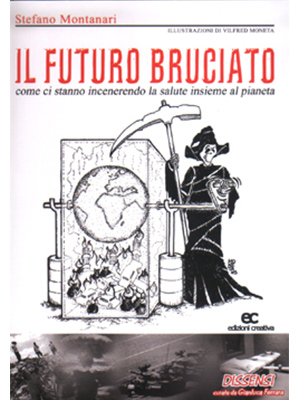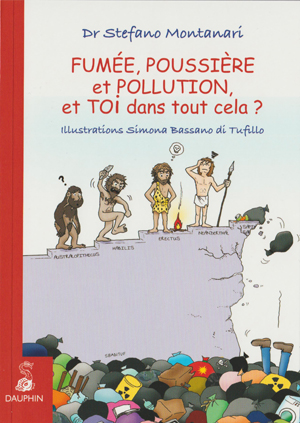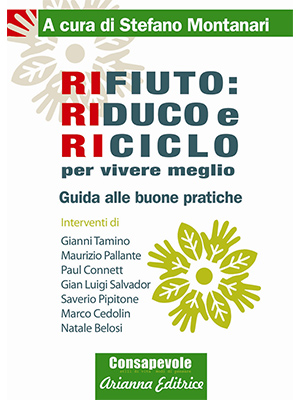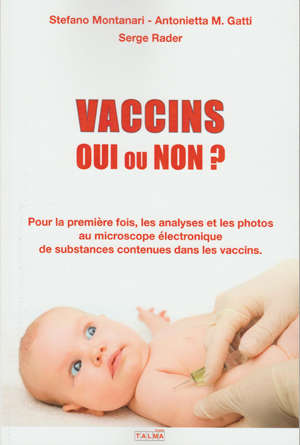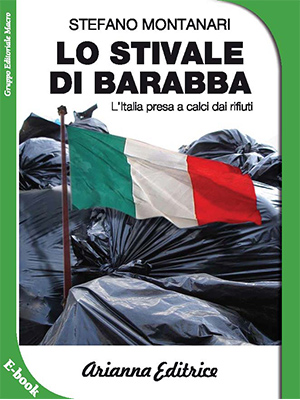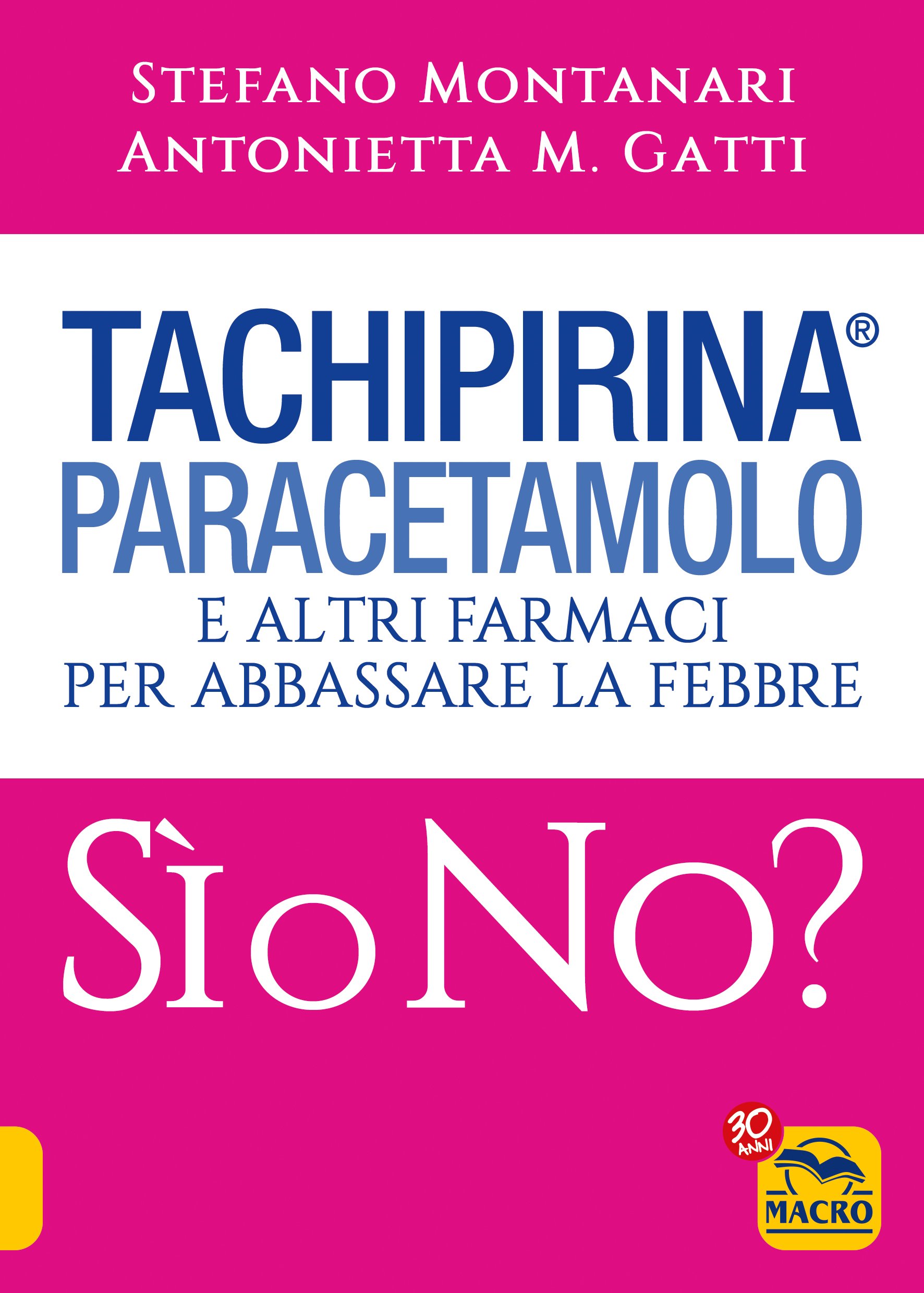La Comunità Europea ha deciso: la pubblicità degli alimenti non può essere ingannevole e le etichette non hanno il permesso di riportare caratteristiche del prodotto che non possano essere provate scientificamente. Insomma, ciò che vedremo sulla confezione corrisponderà a ciò che abbiamo acquistato e rinunceremo così a sognare di perdere qualche chilo che ci sta scomodo, a ripopolare una testa pelata con una chioma degna di Berenice, a correre come un maratoneta etiope e chissà a che altro. Niente sogni ma, in compenso, più tutela.
Basta con gl’inganni, dunque, e tutti sulla strada della più assoluta modernità, però “i sapori di una volta” non si trovano più, almeno non nei cibi sciorinati sugli scaffali e nei frigoriferi del supermercato. Un bel giorno la scienza ha sentenziato che questi “sapori di una volta” erano legati ad alimenti che non offrivano garanzie d’igiene e la distribuzione si è accorta che conservare questi sapori era incompatibile con le nuove esigenze di conservazione, di trasporto e, perché no?, di estetica. Dunque, via i batteri, via la frutta (prendendo la frutta solo per fare un esempio) che marciva dopo due giorni e che, magari, era abitata da un verme, e porta spalancata ai frigoriferi che prolungano con accanimento la vita, magari in coma profondo, dei vegetali, ai trattamenti a caldo, come per le arance, che distruggono sapore e vitamine, alle immersioni nelle camere a gas per controllare la maturazione, alle lacche e, ancora sul campo diventato quasi la prima sezione di una catena di montaggio, a concimi chimici e pesticidi in quantità. Pesche ed albicocche avranno pure il sapore e la consistenza di patate crude e avranno un valore alimentare un po’ miserello, ma saranno asettiche e indistruttibili. Per le vitamine? Ci sono le farmacie apposta. Il rapporto con il cibo, almeno nei paesi in qualche modo privilegiati, diventa sempre più estremo e conflittuale: se da una parte ci sono gli appassionati del cibo “spazzatura”, quelli di scuola fast food che divorano tutto ciò che solletica il loro palato indipendentemente da che cosa questa roba sia, dall’altra crescono i sospettosi, quelli che non si fidano di nulla e di nessuno. Del resto, è inutile negare che “ci scaviamo la fossa con i denti”, almeno in certi casi, e che esistono patologie la cui origine alimentare è chiara o, per lo meno, fortemente sospettabile. Prendiamo, ad esempio, le allergie verso alcuni cibi, allergie che oggi interessano una quantità non solo enorme, ma crescente, di bambini. E la celiachia, cioè l’intolleranza al glutine di frumento e di altri cereali? Perché da noi in Italia è in aumento? E il morbo di Crohn, una malattia dell’intestino che ora si presenta sempre più spesso ed in pazienti sempre più giovani? Oggi che il mondo è diventato così piccolo e che il mercato globale ci mette in tavola alimenti che in poche ore hanno percorso migliaia di chilometri, è inevitabile ritrovarsi a mangiare con questi sostanze appartenenti ad altri sistemi produttivi dove le garanzie non sono quelle della Comunità Europea. Pericoloso? Chissà. Però anche da noi di tanto in tanto si perde il controllo della situazione. Prendiamo, ad esempio, l’encefalopatia spongiforme bovina, quella condizione chiamata familiarmente mucca pazza, o la scrapie, un’affezione molto simile che colpisce gli ovini. Si tratta di malattie neurologiche veterinarie di cui si sospetta una trasmissibilità all’uomo sotto forma di sindrome di Creutzfeld-Jacobs. Negli anni Novanta ne partì dall’Inghilterra una vera e propria epidemia negli animali e questo indusse i legislatori a proibire l’uso dei visceri e del midollo osseo di quel bestiame, il che produsse un certo cambiamento nelle abitudini alimentari e il dissesto di un po’ di allevatori e macellai. Allora il consumatore cominciò davvero a chiedersi, magari un po’ nevrotizzando la situazione, se un cibo potesse nascondere insidie, per di più gravissime, per la salute. Eliminata la farina animale (forse con qualche additivo non propriamente dei migliori) dalla dieta di quel bestiame diventato d’improvviso pericoloso, ecco che l’incidenza della patologia è andata drasticamente diminuendo, frattaglie e bistecche con l’osso sono ritornate legali ed appetite, e media e pubblico hanno perduto interesse all’argomento, anche se l’argomento non è affatto chiuso e qualcosa ci sarebbe ancora da dire. Comunque, questo ha fatto capire che se si alimenta un animale con cibo scadente, l’animale che diventa cibo sarà cibo scadente a sua volta se non addirittura tossico. E se noi, noi uomini, intendo, mangiamo cibo scadente? Al momento i media stanno forse stimando meno del dovuto il problema dell’influenza aviaria che sta colpendo i polli del sud-est asiatico, ma che sta arrivando anche da noi. Polli morti per malattia ce ne sono sempre stati, ma ora sembra che esista la possibilità di un passaggio di specie, il che significa che mangiare un pollo ammalato potrebbe comportare la trasmissione di una patologia che in più di un caso è stata letale. Quanto a possibili cure, il fatto è che non ci sono farmaci per quelle patologie nuove e che i farmaci attualmente sul mercato sono solo dei sintomatici senza reale efficacia contro questi agenti patogeni così poco conosciuti. E allora, quando il consumatore sta di fronte ai banchi dei supermercato resta perplesso ed esita prima di stendere la mano ed acchiappare un prodotto. La scienza non ci dice nulla o, almeno, non ci convince, e la conseguenza è che le scelte vengono fatte emotivamente, con il rischio di distruggere o, comunque, modificare un’economia ed un mercato senza ricavarne alcun beneficio. Altro problema è quello dei concimi chimici e dei pesticidi, usati con enorme liberalità per aumentare la produzione e per evitare che batteri o insetti intacchino il prodotto ma che sono tutt’altro che innocui per l’uomo. Chi non accetta quei prodotti, si rivolga al biologico che, però, ha costi superiori e una varietà minore di scelta. Ma, come ho detto e come tutti sappiamo, in un mercato globale ortaggi e frutta possono provenire da tutto il mondo. Ecco che allora li riceviamo trattati con pesticidi che nel nostro continente sono stati messi fuorilegge da molti anni. Ecco che questi prodotti ce li ritroviamo messi in vendita senza i controlli specifici per quelle sostanze, come è ovvio che si faccia per sostanze ormai obsolete.E c’è un’altra preoccupazione che si sta facendo strada. Non è un mistero che l’uomo si sta ammalando con frequenza crescente per l’inquinamento dell’ambiente in cui vive, ma come reagiscono a tutto ciò animali e vegetali materie prime? Inquinamenti ambientali creati da combustioni ad alta temperatura come fonderie, inceneritori o motori a scoppio possono sicuramente aggredire frutta e verdura che può a sua volta trasferire questa contaminazione all’uomo ed agli animali. Mangiando frutta e verdura globalizzate possiamo mangiare inquinamenti di altri paesi dove non esistono le nostre stesse leggi. Ad esempio, mangiando i pomodori cinesi in scatola (già abbondantemente sul mercato) si possono ingerire i pesticidi degli anni 50 che da noi sono vietati. Oppure mangiando pesce egiziano possiamo contaminarci con l’inquinamento di città ed industrie che non hanno le nostre norme di sicurezza e il cui inquinamento è finito, soprattutto tramite i corsi d’acqua, in mare. A questo quadro non proprio idilliaco si aggiunge anche il cibo “nano”. L’industria alimentare ha scoperto che alcune particolari nanoparticelle inserite nel cibo sono in grado di cambiare la viscosità di fluidi come certe salse o di stabilizzare una miscela. L’inserimento di nanoparticelle di biossido di titanio in certi tipi di cioccolato, ad esempio, evita che il cacao si separi dal burro di cacao con l’andare del tempo, risparmiando allo schizzinoso consumatore quella antiestetica patina bianca che fa poco appetibile il prodotto. In quel caso, il consumatore si mangia un cioccolato bellissimo, però pieno di polveri minuscole che non hanno alcun potere nutrizionale, non si digeriscono, non si eliminano e non si degradano. Compatibili con l’apparato digerente? La perplessità è grande. Di certo, nessuno ha dimostrato che lo sia. Eppure questa roba non è dichiarata in etichetta. Di quelle aggiunte abbiamo dimostrazione con fotografie al microscopio elettronico, ma i produttori continuano imperterriti a non dichiarare nulla in etichetta, come se si trattasse di un fatto irrilevante, come se l’aggiunta di prodotti nanotecnologici di cui si sa poco e che si pretende d’ignorare fosse solo un fatto interno della ditta che non riguarda il consumatore. Il Progetto Europeo Nanopathology ha già dimostrato che polveri ambientali anche più piccole di un millesimo di millimetro si trovano con frequenza dentro o nelle vicinanze di certi tessuti patologici come, ad esempio, varie forme di cancro. Dunque, non dovrebbero esserci dubbi sul diritto del consumatore il poter almeno scegliere se mangiare prodotti nanotecnologici, quelli in cui le polveri si mettono a bella posta, o evitarli. La paura di distruggere un mercato remunerativo e in crescita come quello del cosiddetto Nanofood consiglia al produttore di non informare il consumatore. In passato la percezione di un rischio ignoto, di quanto non dimostrato scientificamente, ha indotto il consumatore a rifiutare i prodotti OGM (organismi geneticamente modificati), e non si vuole cadere in un flop analogo, ma dall’altra parte nascondere la verità è un rischio ancora maggiore, stante l’impossibilità pratica di tener segrete certe cose in un mondo in cui la comunicazione ha raggiunto concentrazione, velocità e disponibilità mai sperimentate e non controllabili. Qui, allora, entra in gioco il popolo, se una parola così antica e impegnativa mi è permessa. Bisogna che il popolo sovrano imponga a tutti gli enti, Comunità Europea compresa, di obbligare i produttori a segnalare con chiarezza in etichetta la presenza eventuale di nanoparticelle nella loro mercanzia e di richiedere la prova scientifica inconfutabile che questo materiale inorganico non biodegradabile non abbia alcun effetto negativo sulla salute. Mal che vada, ci mangeremo la cioccolata con la patina bianca.