Ormai è passato qualche decennio dal dissolvimento dell’Unione Sovietica e da allora molte cose sono cambiate. Non tutte in meglio, occorre dire e, in verità, c’è più di qualcosa che è
restato com’era.
L’Uomo e gli avvenimenti che lo caratterizzano non sono figli di particolare fantasia. Anzi, tralasciando particolari legati al periodo storico e all’ubicazione geografica, i pochi canovacci restano immutati e probabilmente immutabili.
Come si dice sempre riesumando Giambattista Vico e prendendosi un po’ gioco di uno dei suoi capisaldi filosofici, la Storia sarà sì maestra di vita ma di allievi ne ha ben pochi.
Ecco un racconto che, pur essendo frutto di fantasia, è basato su fatti realmente accaduti e accaduti spesso.
Per il sollievo dei miei occhiuti controllori, quello che segue non darà loro problemi e li solleva dal triste e noioso obbligo di leggermi.
Prometto che la prossima volta, quando vorrò dare una tregua, metterò sul blog qualcosa di più divertente.
I BARATTI
La terra è ancora gelata e spaccarla è una bella fatica. Mi perdonerà, signore, se per ora mi fermo qui e rimandiamo tutto. Del resto, data la situazione, non credo che lei abbia fretta.
L’avevo vista arrivare da lontano, sa, con la camionetta, come tutti quelli che vengono per cacciare. Non creda: anche se qui le sarà sembrato di essere in capo al mondo, gente ne arriva. Cacciatori come lei. Cacciatori… Da quando è andato tutto per aria, da quando la legalità non c’è più, qui c’è l’anarchia. Dappertutto c’è l’anarchia. Una volta, guai a cacciare! Tutta selvaggina proibita, protetta! Solo loro, quelli autorizzati, con tutti i documenti in ordine, i timbri, le firme… solo quelli potevano venire e le pelli dovevano arrivare tutte da noi. Se ne pizzicavano uno fuori posto… Adesso invece…
Viene ancora buio abbastanza presto di questa stagione. Poi, più avanti, il sole non se ne va mai: scende, arriva all’orizzonte, sembra che sprofondi, e invece, op! su di nuovo. Le fa un giro di traverso sopra la testa e giù non ci va. E non fa più freddo, sa. La terra non è più gelata e, quando capita, si scava bene. Vede: qui intorno di buche ce n’è più d’una. Le più profonde sono quelle che faccio d’estate.
Ma ormai è tardi e per oggi mi pare possa bastare. Adesso ci riposiamo fino a domani, e domani vediamo.
Non mi dispiace avere gente. Anzi, mi piace. Una persona alla volta, ogni tanto, fa piacere. Se arrivano in due o tre è più complicato, invece; però ce la faccio lo stesso. La zuppa da preparare… Prima loro mi raccontano che cosa succede lontano da qui, nelle città, nelle altre nazioni… Dipende da dove arrivano. A volte ci si capisce appena, come con lei. Poi, quando loro hanno finito, quando tutto è finito, racconto io, così, per tenere a mente quel che mi è capitato. A dire la verità, non racconto per loro: a loro non può interessare. Lo so, nemmeno a lei… Non creda: mi rendo conto benissimo che non c’è niente di straordinario nella mia vita. Non c’è niente di più insignificante del caso, degli avvenimenti. Noi viviamo per vivere, per fare tutto il cammino tra la nascita e la morte. Quel che succede in mezzo non ha nessuna importanza: quel che importa sono gli estremi, partenza e arrivo. A volte qualcuno si prende la briga di scrivere sui libri: perché viviamo? Perché viviamo! Ma che importa? Che diavolo ne sappiamo? Che diavolo ne possiamo sapere? Perché scervellarci con queste sciocchezze? Noi dobbiamo vivere e basta: vivere fino a morire. Vivere fino a morirne, qualche volta. Il resto lasciamolo pure agli sfaccendati, ai filosofi, ai pazzi, che poi fa lo stesso. Libri ne ho letti, sa: una volta ne leggevo tanti. Quante sciocchezze! Quante domande pomposamente stupide! Le domande intelligenti sono solo quelle che hanno una risposta. Le altre sono un esercizio di autocompiacimento.
Basta! Non voglio mettermi proprio io a filosofeggiare.
Prima che venga il momento di dormire… La mia vita… Io ero innamorata di mio cugino. Ogni volta che dico questa frase mi viene da ridere. Non mi vedo più da anni, da anni non ho più uno specchio e neanche vorrei averne uno, però mi vedo le mani: grinze, macchiate. Con queste manacce mi tocco la faccia: anche questa deve essere orrenda, come un campo arato, di quelli che ci sono dove non fa così freddo e i campi si possono arare. Le sento sotto le dita, le rughe. E i denti! Ogni tanto me li conto con la punta della lingua: undici. Me ne sono rimasti undici e non è detto che questo che mi scuote un po’ regga ancora a lungo.
Beh, insomma, io ero innamorata di mio cugino. Non mi chieda perché: tanto non saprei dirglielo. Lui era molto più vecchio di me: io ventisette anni, lui sessanta. Il doppio. Più del doppio. Trentatré anni fra noi due. Non era proprio mio cugino: sua madre era la sorella di mia nonna.
Io facevo la maestra. Per questo leggevo i libri. Mio cugino faceva lo scrittore, anzi, il commediografo. Scriveva drammi che si rappresentavano non di nascosto, ma quasi. Loro, quelli del regime, non vedevano di buon occhio la sua roba, ma lui era intelligente e scriveva in modo che era quasi impossibile censurare. Tutto nella legalità. Faceva anche il giornalista: cronaca, niente di speciale. Per sopravvivere. Come tutti, del resto. Sopravvivere, vivere, fa lo stesso.
E’ inutile che le racconti la mia storia d’amore: sono tutte uguali, e poi da una vecchia suonerebbe ridicola e, chissà, anche schifosa. Alla fine ci sposammo.
Riuscimmo a trovare una stanza. Lei viene da fuori e non può capire. Nessuno che venga da fuori capisce. Trovare una stanza non era facile e, da quanto so, non è facile neanche adesso. Bene, trovammo questa benedetta stanza e ci andammo a vivere.
Lui era malato da prima. Io lo sapevo. Quando gli venne lo sbocco di sangue grosso, lo presero in ospedale. Il bambino ce l’avevo già dentro. C’era, anche se si muoveva poco.
Lo andavo a trovare tutti i giorni, dopo la scuola. “Non venire – diceva lui: – il bambino…” e mi toccava la pancia con le dita sudate, bianchicce che sembravano candele. Moriva piano piano, lasciando un figlio che sarebbe dovuto nascere per poi morire. Una vita da percorrere, come tutti. L’avevamo fatto insieme, quel bambino, senza sapere perché, come succede sempre. “Sono l’interposta persona di dio,” diceva quando mi toccava la pancia. Ma bisogna perdonarlo: gli scrittori…
In ospedale non gli davano abbastanza da mangiare. Così diceva sua sorella. Lui no, lui non diceva niente. “Il burro ci vuole,” mi disse in un orecchio l’infermiera. Ma dove lo trovavo, io, il burro? “Il burro…” mi ripeteva quella ogni volta che la incrociavo nel corridoio.
Era estate quando il bambino nacque. Era estate e non c’era scuola.
“Non portarmelo, mio figlio” diceva lui. Non si sa come, era ancora vivo: moriva a poco a poco, con una lentezza esasperante. Il bambino, così piccolo, non si poteva portare in ospedale. “Non portarmelo.” Però lui voleva vederlo, io lo sapevo. Se l’immagina? il pensiero lo fece migliorare. Non fu il burro: quello se lo portava via tutto l’infermiera. Doveva pur vivere anche lei, si capisce… Lo lasciarono venire a casa per una settimana. Morì lì.
Il bambino non era sano. “Non ci si sposa tra parenti, – dicevano – e a quell’età non si fanno figli.” Sì, io lo sapevo: era scritto sui libri. Ma che cosa importa? Si nasce, si muore… quel che ci sta in mezzo non conta.
Erano passati due anni e al bambino gli cascava la testa sulle spalle, sul petto. Bisognava rimettergliela a posto come se fosse quella di un burattino. Aveva sempre un po’ di febbre. “Deve mangiare meglio,” diceva la sorella di mio marito. Lui mangiava poco, e, quel poco, di malavoglia. “La carne – diceva lei.- Se hai trovato il burro, devi trovare la carne.”
Tra i miei allievi ce n’era uno più piccolo degli altri, più basso, più gracile. Non capiva meno dei suoi compagni: era solo timido, molto timido. Suo padre era un funzionario del partito e non si capiva come un funzionario del partito potesse avere un figlio così malmesso. Beh, io cominciai a dargli dei compiti più difficili di quelli che davo agli altri, ad interrogarlo e a fargli domande astruse. Lo facevo piangere. Suo padre venne a trovarmi. “Lo dovrò bocciare,” gli dissi. Lui mi portò un pezzo di carne. “Va meglio, – gli dissi un paio di settimane dopo – però per promuoverlo…” Mi portò due sacchi di farina bianca.
I sacchi li portai a casa di nascosto. Usare la farina nella cucina in comune non è facile: fa profumo. A mio figlio piaceva, un po’ mangiava, ma la testa continuava a cascare.
Una sera arrivarono quattro poliziotti, sequestrarono il sacco e mezzo che era rimasto e mi portarono via.
Al processo saltò fuori che avevo rubato la farina da un deposito dell’esercito e i poliziotti dissero che ne avevano trovato solo mezzo sacco. Anche loro dovevano vivere.
La condanna fu a diciotto anni da scontare in un campo, ai lavori forzati per rifondere il danno che avevo provocato allo stato. Gliel’ho detto: allora c’era la legalità e con la legalità non si scherza.
Mi caricarono sul treno con quattro o cinque altre donne. Due giorni ci vollero. Più di due giorni: due in treno e mezza giornata per il resto del viaggio sul camion.
Di questi posti si sentiva parlare. I campi. Mio marito diceva che ce n’erano per gli scrittori, per gl’intellettuali, ma lì, dove stavo io, eravamo tutte delinquenti comuni.
Quando si arriva è brutto: non sai come funziona, non sai come si fa ad evitare che le altre ti portino via il mangiare, non sai perché ti picchiano e fai degli errori. Poi, in fretta, s’impara tutto: il nome delle altre, quello dei guardiani, i loro gusti… S’impara ad evitare il lavoro: metti un dito in una bottiglia e la sbatti contro il muro. Il dito si spacca e per un po’ stai tranquilla. Questo, però, non si può fare spesso. La cosa migliore è farsi fare un’iniezione di petrolio, ne basta poco, e ti viene la febbre, la febbre alta, e per qualche giorno a conciare le pelli ci vanno le altre. Conciare le pelli fa male, si usano i veleni, lei lo sa.
Io ero bella, dicevano, e, quando lo chiedevo, l’infermiere mi faceva la puntura di petrolio. Non pretendeva gran che in cambio. Il dottore prima voleva la sua parte e poi mi faceva il certificato con il timbro e per qualche giorno…. Io ero fortunata: non mi picchiavano perché ero bella e mi volevano tutta intera. Pensi che non mi lasciavano nemmeno mettere l’acido sulle palpebre per farmi venire l’irritazione. Solo le punture di petrolio mi lasciavano fare, perché se una non ha proprio niente non si può mica lasciare a letto. Riuscivo anche ad avere qualcosa in più da mangiare come ero riuscita ad avere il burro per mio marito. L’unica cosa a cui non riuscivo ad adattarmi era non sapere niente del bambino. La natura è strana… Un giorno, però, era passato un anno, arrivò la notizia che era morto. Fu un sollievo, lei capisce: così piccolo, lui aveva già fatto tutto quel che doveva fare.
Le ho detto che ero bella, almeno così mi dicevano, e per bella mi trattavano. La bellezza, però, è un patrimonio su cui non si può fare conto. Il fatto è che era arrivato un carico di prostitute e alcune erano belle davvero, e in più conoscevano il mestiere. E poi erano passati sette, forse otto anni e al campo s’invecchia in fretta, anche se si conoscono i trucchi, anche se si è imparato come si fa a far sparire il cibo di quelle che arrivano. Neanche l’infermiere mi voleva più e allora, se non ce la facevo ad andare a lavorare, mi dovevo mettere l’acido della concia negli occhi. Non mi volevano più e, quando arrivavano i guardiani ubriachi, qualche botta la prendevo. A volte sparavano anche, sa. Lo facevano così, per divertirsi. Per dei giovani il campo è noioso e allora qualcosa bisogna pur inventarsi per passare il tempo. I più vecchi bevevano l’alcol dell’infermeria. Uno era diventato cieco per questo, almeno dicevano.
Un giorno, ero ormai all’ultimo anno, arrivò una ragazza. “Io non ho fatto niente – diceva: – sono qui per errore.” E piangeva. Mi si era attaccata tanto che non riuscivo nemmeno a portarle via la minestra. Non si dava pace, piangeva e strillava quando la picchiavano e scalciava quando la portavano nella casermetta. “E’ inutile agitarsi – le dicevo io: – tanto fanno i loro comodi lo stesso.” Una volta mi hanno fatto abortire e io non mi sono mica lamentata, sa. “Io scappo,” diceva lei. “Ma dove vai? Se ti beccano t’ammazzano, e poi, fuori non c’è da mangiare, di notte fa freddo anche se è quasi estate…” “Non m’importa: io scappo.” Pensi: voleva che scappassi con lei. Beh, una mattina non c’era più sul serio: era scappata davvero e nessuno si dava la pena di cercarla. I guardiani ridevano: “Si è andata ad ammazzare,” dicevano ad alta voce, perché noi sentissimo.
Fu quasi alla fine dei miei diciotto anni che successe il patatrac. Loro, i guardiani, non ci dicevano niente, però era chiaro che non era più come prima. Quasi d’improvviso avevano smesso di controllarci come si doveva, poi gli orari cominciarono a non essere più quelli: un giorno si lavorava dodici ore, il giorno dopo, magari, quattro o cinque e poi tutte nelle baracche. Le pelli restavano ammonticchiate e non le contavano. Il camion non arrivava più, il camion con le detenute nuove e con il cibo. Fu proprio il cibo a far crollare tutto. Non c’era più da mangiare e i guardiani se ne andarono. Semplicemente così: andarono via lasciandoci là. Uscimmo tutte, senza che nessuno ce lo impedisse. Eravamo tutte cariche delle cose che avevamo portato via dalla casermetta, quelle cose che i guardiani non s’erano prese. Una di noi aveva staccato un orologio dal muro e se lo portava in spalla. Camminammo per giorni verso nord, lungo il fiume, discendendolo verso il mare. Cinque giorni, sei, forse. Non ricordo. Ogni tanto c’era da attraversare un affluente ed era un bel problema. Non sapevamo dove ci trovavamo. Pensi, tanti anni al campo e nessuna si era mai chiesta dove fossimo davvero sulla carta geografica. Camminavamo pensando che, prima o poi, avremmo trovato qualcosa, un paese, una casa, il mare. Come se il mare… Speravamo. E invece, niente: avanti, avanti, e di lì sembrava di esserci passate il giorno prima, un’ora prima. Tutto uguale.
Non c’era da mangiare, naturalmente, a parte un sacco di pane un po’ ammuffito che avevamo trovato in cucina. Ce lo dividevamo, un pezzetto per ognuna, un po’ al mattino e un po’ alla sera. Saremmo morte tutte, non c’era dubbio. Qualcuna piangeva, anche se non ce n’era ragione.
Una notte in cui il sacco ce l’avevo in custodia io, lo presi e me ne andai, senza che nessuna se ne accorgesse. Ritornai indietro per non farmi trovare, risalendo il corso del fiume e poi lungo un affluente: più o meno la continuazione della strada che ha fatto lei con la sua… con la camionetta. La mattina arrivai qua, in questa capanna, e sa chi ci trovai dentro? La ragazza che era evasa quasi un anno prima. Morta, come avevano detto i guardiani. Però aveva lasciato una pila di scatole di aringhe e dello stoccafisso. E c’erano delle pelli come quelle del campo. Non riuscivo ad immaginare dove avesse preso quella roba, ma la cosa non aveva importanza: c’era da mangiare. La ragazza la seppellii qui fuori perché forse non era tanto che era morta e puzzava.
Non avevo deciso che cosa fare. Cibo ce n’era per un po’, per parecchio tempo, anzi, ma non sarebbe durato in eterno, e lì non c’erano mica quelli del campo, che ti picchieranno pure e faranno anche i loro comodi con te nella casermetta ma che ti danno da mangiare. Dovevo per forza ripartire, ma in che direzione? E per andare dove? Che cosa avrei potuto fare io, non ancora troppo vecchia ma ridotta in una maniera… Se mai fossi riuscita a raggiungere una città, un paese, che cosa avrei potuto fare? E poi ero un’evasa e se mi avessero presa…
Però a volte la fortuna… Saranno passati sì e no quattro o cinque giorni e sento il rumore di un camion che si avvicina. Cerco di nascondermi, ma qui, come ha visto, nascondigli non ce ne sono. Non crescono mica gli alberi, qui. Pensavo fossero venuti a riprendermi. Invece dal camion esce una persona sola e chiama la ragazza, la chiama per nome. Ma la ragazza era morta, sepolta appena lì fuori e quel tizio, senza saperlo, ci camminava sopra. Insomma, era arrivato il camion di uno che le portava delle pelli da cucire, delle pelli che venivano dai cacciatori di frodo. Il paese era lì, a un giorno di cammino e io non lo sapevo. Il paese con la gente c’era, però lui, quello del camion, non poteva farci lavorare le pelli: se qualcuno, un poliziotto, se ne fosse accorto, avrebbe passato dei guai.
Adesso, ormai sono anni, lui mi porta le pelli con i veleni per conciarle e io glie le concio, glie le lavoro, glie le cucio. Lui mi ha dato i vetri per le finestre, le coperte, mi dà lo stoccafisso, le aringhe, la carne secca. Delle patate, anche. Un giorno mi ha portato un libro. Un libro… E’ ancora lì, mai toccato. Quando capita, io gli do delle munizioni, qualche fucile, dei soldi, e lui mi porta dei vestiti, del petrolio da mettere nella stufa, i fiammiferi… di tutto, insomma. Si baratta. No, non sto male. In paese non ci andrei. Non c’è più legalità e non credo che me la passerei troppo bene. Non c’è più legalità: è un bene ed è un male. Un bene per me, perché se anche qualcuno sapesse che sono evasa, nessuno se ne curerebbe. Però senza legalità…
Di tanto in tanto arrivano i cacciatori stranieri e si fermano qui da me. Adesso, dopo il patatrac, si va a caccia delle bestie protette. Tanto, nessuno dice niente. Vengono da me e io gli do la zuppa. Non si può fare il fuoco qui: qui è tutto di legno. La zuppa la cuocio là fuori, nel riparo dove tengo i bidoni con i veleni della concia.
Stavolta, quando arriva quello del camion, forse a fine settimana, gli darò anche la camionetta. Mi farò portare della frutta. Qui da noi la frutta non c’è, sa. Non è come da voi: qui la frutta viene da chissà dove e costa cara. Gli darò la camionetta e mi farò aiutare a scavare la buca perché ormai, alla mia età, faccio fatica. Per questi quattro o cinque giorni mi perdonerà, signore, se non potrò ospitarla nella capanna. Capirà, i cadaveri puzzano.


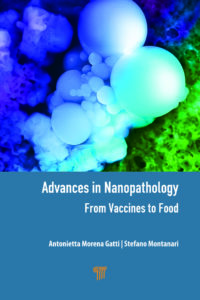

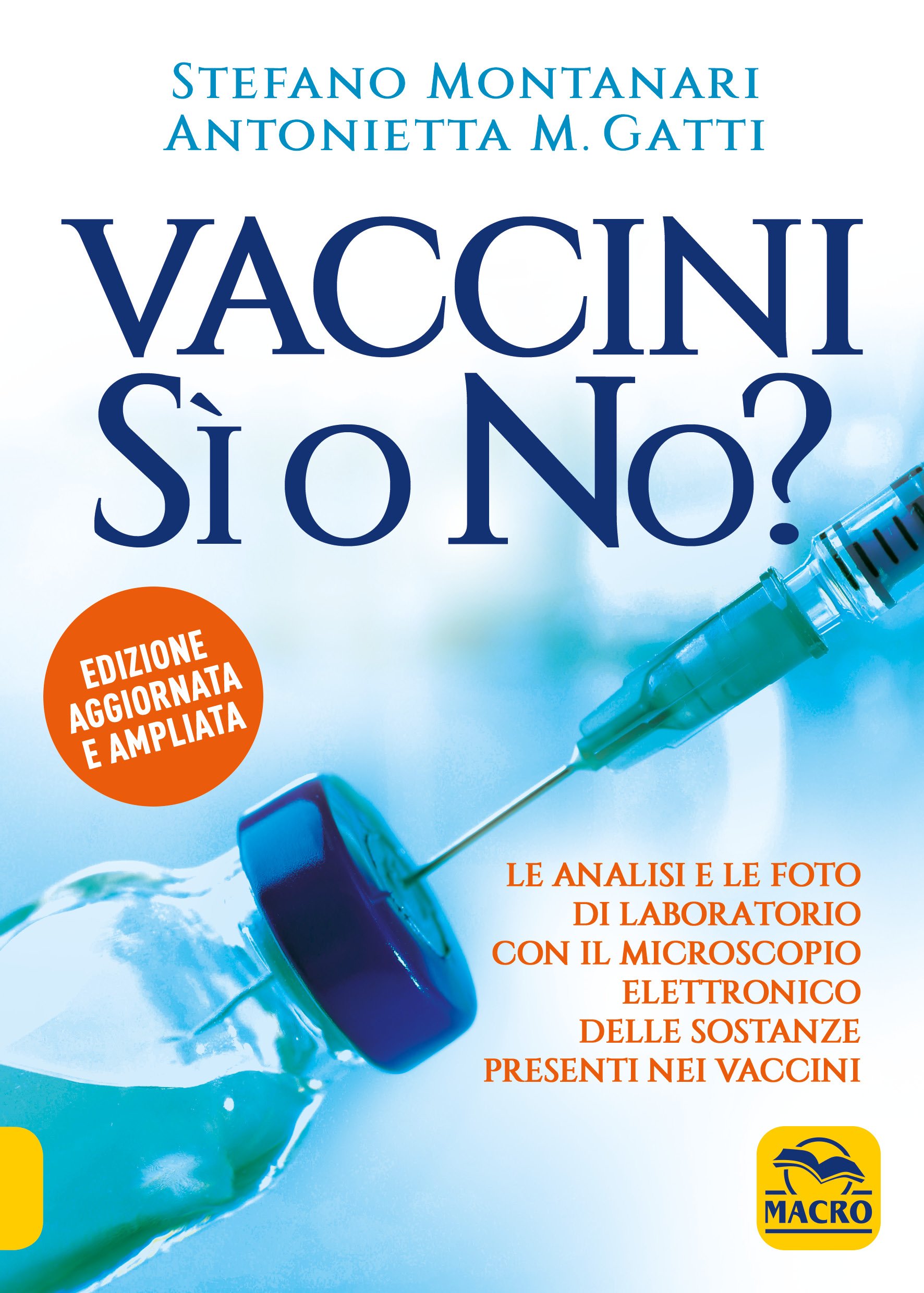
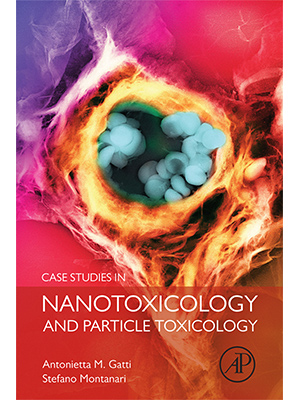




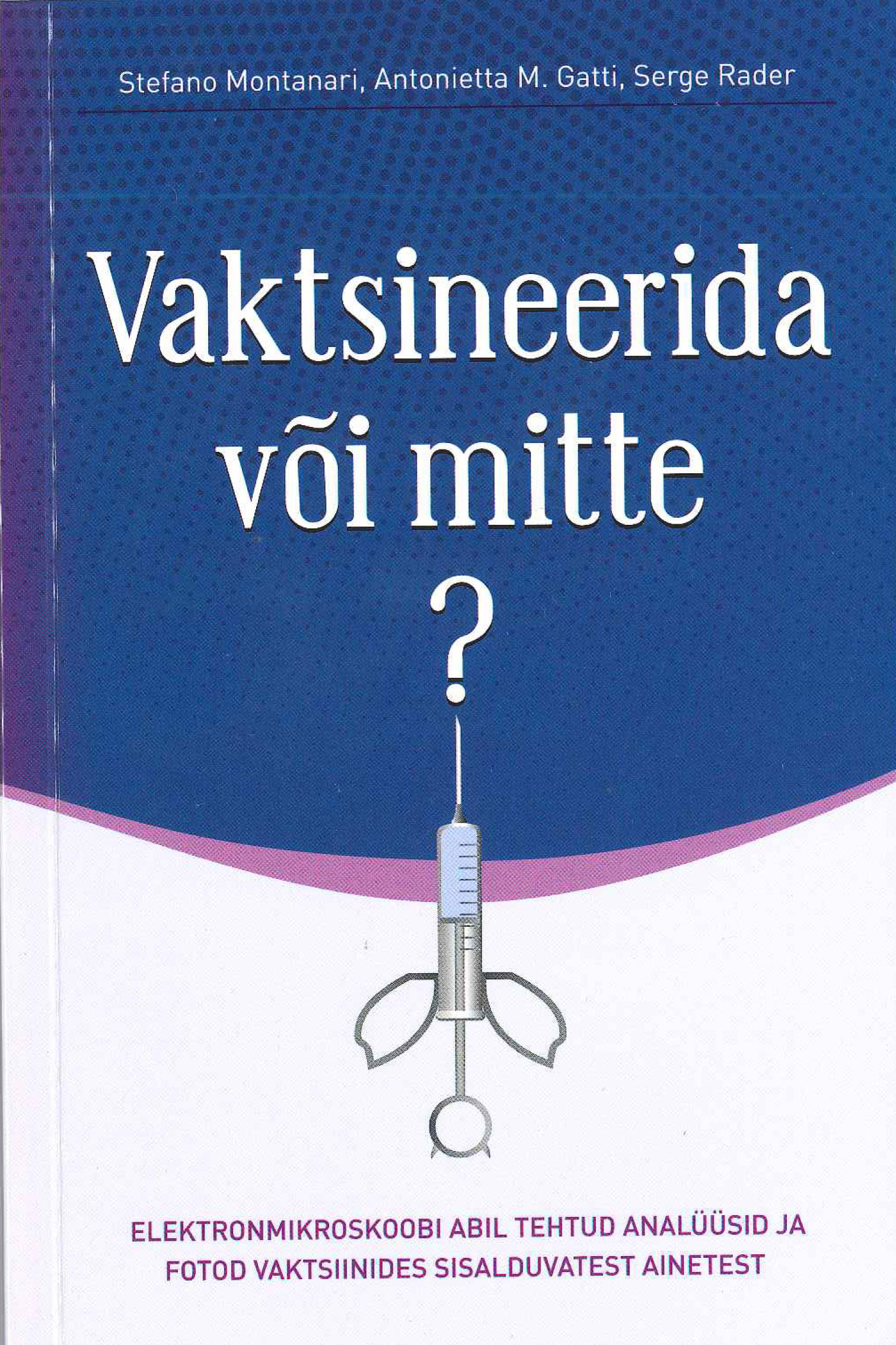
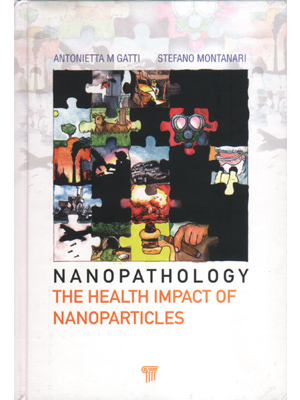




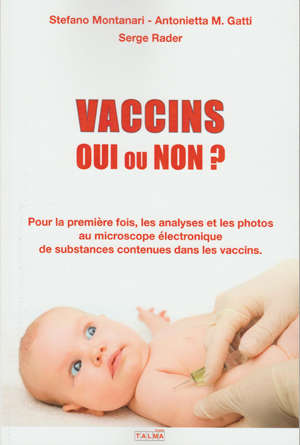


Bellissimo
Lo so,sono ripetitiva.
Un altro racconto molto bello.
Mi piace molto il suo modo di scrivere.
Appena pubblica il libro 😉 io lo compro.
Rinnovo i miei complimenti
RISPOSTA
Grazie. Il libro non lo pubblicherò mai. Ciò che io scrivo non fa fatturato per gli editori.
Senza titoloQuesto racconto esprime un sentimento amaro della vita, definita come un intermezzo tra il nascere e il morire che non vale la pena di cercare di riempire in un modo piuttosto che in un altro, perché, al netto delle illusioni, l’esistenza umana è quello che è. Forse da questa consapevolezza nasce nell’animo della protagonista un senso di rassegnazione, nel quale si intravvede una forma incredibile di serenità: se la vita è quello che è allora basta davvero poco per accettarla. Il filosofo Schopenhauer diceva che la felicità e l’infelicità non sono altro che il passaggio da uno stato peggiore… Leggi il resto »