Avevo iniziato a scrivere un articolo sul TAV (maschile: Treno Alta Velocità). Poi ho pensato che mille volte meglio di me poteva fare Marco Cedolin, valsusino d’adozione.
Quello che segue è estratto dal suo libro Grandi Opere (da leggere con l’Alka Seltzer a portata perché le informazioni che sono scritte e che nessuno ci dà fanno venire la dispepsia) con un finale scritto ora. (SM)
Fin dal momento della sua nascita il progetto TAV fu propagandato all’opinione pubblica attraverso l’uso sistematico della menzogna. Nei proclami di coloro che nel 1991 la presentarono alla stampa, l’infrastruttura avrebbe dovuto essere finanziata per il 60% da capitale privato, sarebbe statadestinata ad ospitare esclusivamente treni passeggeri e avrebbe comportato un costo di 26.180 miliardi di lire.
In realtà gli investitori privati non esistevano affatto, come emerse pubblicamente alcuni anni più tardi, i potenziali passeggeri sarebbero stati pochissimi, per cui nel corso del tempo la destinazione d’uso fu allargata al trasporto delle merci ed il costo dell’opera lievitò in maniera esponenziale fino a raggiungere nelle stime più attendibili la stratosferica cifra di 90 miliardi di euro.
Per giustificare l’utilità e la necessità dell’opera sono state accampate nel corso degli anni le ragioni più disparate, destinate a venire regolarmente smentite dalla realtà oggettiva dei fatti e dal giudizio degli esperti che si esprimevano riguardo al loro campo di competenza. Questo poiché in realtà il progetto TAV non interpreta nessuna delle esigenze connaturate alla movimentazione di merci e persone presenti nel nostro paese.
La prima motivazione a sostegno dell’alta velocità ferroviaria è stata quella di potere offrire ai viaggiatori italiani la possibilità di spostarsi in maniera più rapida.
Il sistema TAV è però strutturato in maniera tale per cui la velocità si traduce in risparmio di tempo solamente quando la distanza da percorrere è di una certa rilevanza (generalmente superiore ai 300/400km.) dal momento che su tratte più brevi il tempo risparmiato non sarebbe apprezzabile e risulterebbe impensabile imporre ad un treno ad alta velocità molte fermate intermedie che per forza di cose ne vanificherebbero le prerogative di rapidità. Secondo studi compiuti dalle stesse ferrovie l’80% dei viaggiatori che utilizzano la rete ferroviaria italiana è però composto da passeggeri che effettuano viaggi inferiori ai 100 km. e non trarrebbero dalle nuove linee TAV alcun genere di utilità. Una parte di coloro che compiono viaggi più lunghi sceglie il treno per la sua convenienza economica e non sarebbe disposta a barattare un eventuale risparmio di tempo a fronte di un incremento sostanzioso del prezzo del biglietto e molti fra i viaggiatori che coprono distanze superiori ai 500 km dichiarano che qualora interessati ad un risparmio di tempo, in presenza di costi del biglietto assimilabili, privilegerebbero il trasporto aereo.
Queste semplici osservazioni dimostrano in maniera inequivocabile come il TAV possa ambire ad interpretare le esigenze di una esigua minoranza dei viaggiatori italiani, il cui numero non sarebbe assolutamente sufficiente per giustificare e rendere remunerativo un investimento di siffatte ciclopiche dimensioni. Di contralto la stragrande maggioranza di coloro che abitualmente usano le ferrovie non domanda treni super veloci bensì un maggior numero di convogli per i pendolari, un servizio più efficiente, maggiore puntualità, carrozze più pulite e attenzione per la sicurezza, tutte prerogative che a differenza del TAV avrebbero comportato modesti e mirati investimenti economici.
Di fronte alla debolezza delle argomentazioni concernenti i passeggeri, intorno alla metà degli anni 90 la motivazione principe della nuova infrastruttura traslò dal trasporto delle persone a quello delle merci. All’alta velocità (TAV) si affiancò l’alta capacità (TAC) e l’opera venne proposta come un sistema in grado di rispondere alle necessità logistiche delle aziende e come una panacea utile a decongestionare le caotiche autostrade italiane spostando le merci dalla gomma alla rotaia, attribuendo in questo modo al progetto anche una velleità ecologica.
La poca realisticità di queste motivazioni traspare già da una prima analisi della costituzione del territorio italiano, caratterizzato da molte piccole e medie città, situate a distanze relativamente brevi le une dalle altre. Questa componente tende per forza di cose a sfavorire il trasporto delle merci tramite ferrovia, poiché tale sistema di trasporto si rivela ideale quando si tratta di coprire lunghi tragitti superiori ai 400 km, mentre diventa antieconomico ed improponibile man mano che la distanza da coprire diminuisce. Già questa realtà oggettiva, ben nota a tutti gli esperti che si occupano di trasporti, dimostra come in Italia ben difficilmente si riuscirà a ridurre significativamente il transito dei mezzi pesanti, poiché la distribuzione capillare delle merci, dovuta anche alla disposizione delle nostre città, coinvolgerà sempre e comunque il trasporto su gomma.
Molto calzante a questo riguardo è l’esempio prodotto da Angelo Tartaglia, docente di fisica nucleare presso il Politecnico di Torino. Tartaglia pone il caso di un qualche imprenditore che sia intenzionato a trasportare il camion su rotaia. L’imprenditore deve caricare le merci sul camion, raggiungere lo scalo più vicino, aspettare che tutto il treno si riempia, poiché il treno non parte vuoto, poi essere trasbordato allo scalo di arrivo e da li raggiungere il destinatario. A conti fatti gli converrebbe decisamente spedire direttamente via camion, sia per quanto concerne i costi, sia per quanto riguarda i tempi. Perciò, sempre secondo Tartaglia, anche se si rendesse più attraente il trasporto su rotaia, e lo si potrebbe fare aumentando l’affidabilità e non certo la velocità, non si supererebbe comunque il volume del 30% a fronte del valore attuale di traffico merci su ferrovia che è del 12%.
Si tratta dunque di una prospettiva d’incremento molto modesta per la quale sarebbero impensabili investimenti faraonici (come quelli destinati al TAV) mirati oltretutto ad incrementare la velocità e non come richiesto l’efficienza e l’affidabilità.
Angelo Tartaglia entra anche nel merito dell’incongruenza costituita dall’intenzione manifestata nel progetto di far correre sulle nuove linee ad Alta Velocità un traffico esagerato e costante, alternato tra merci e passeggeri. I treni che devono correre a 300 km/h (TAV) sono treni leggeri che necessitano di binari perfettamente lisci. Facendo correre sugli stessi binari a 160 km/h treni che pesano 1000 tonnellate per convoglio (TAC), non si può evitare di lasciare sui binari pesanti tracce che richiedono una manutenzione altrettanto pesante, prima che possa passare un nuovo convoglio passeggeri a 300 km/h. Bisognerebbe perciò investire cospicue somme in tale manutenzione ed avere il tempo per farla, caratteristica quella temporale, non compatibile con gli altissimi volumi di traffico previsti nel progetto.
In Francia e in Giappone, fa notare ancora Tartaglia, sulle linee ad Alta Velocità passano solo treni passeggeri, in Francia i treni non viaggiano di notte, quando viene effettuata la manutenzione.
Queste semplici riflessioni, sistematicamente ignorate dall’informazione mediatica ma facilmente riscontrabili interpellando qualunque esperto di trasporti e logistica, dimostrano inequivocabilmente come oltre ai passeggeri non esistano neppure le merci necessarie per motivare un’opera come il TAV. I traffici passeggeri e merci previsti nel progetto sono un puro esercizio di fantasia totalmente disancorato dalla realtà e perfino la destinazione d’uso delle nuove linee (passeggeri e merci) non appare compatibile con i limiti fisici dell’infrastruttura e lo sfruttamento intensivo della stessa che il progetto propone.
Nella migliore delle ipotesi quando l’opera sarà terminata ripercorrerà le orme di Eurotunnel, manifestandosi come un’infrastruttura sotto utilizzata destinata a produrre ogni anno una cospicua perdita di esercizio che sommata all’esorbitante costo di costruzione, peserà però in questo caso sulle spalle di tutti i cittadini italiani e non di un ristretto gruppo d’investitori privati.
Anche le velleità ecologiche del progetto TAV appaiono chiaramente pretestuose e disancorate dalla realtà.
Se infatti da un lato non esistono dubbi sul fatto che sia preferibile in termini d’inquinamento e risparmio energetico trasportare le merci sulle normali linee ferroviarie anziché per mezzo dei TIR, dall’altro non si riesce a comprendere come il TAV potrebbe contribuire a conseguire questo proposito, proponendo un’infrastruttura e dei treni con un impatto ambientale enormemente più elevato rispetto a quelli tradizionali.
Abbiamo già visto come il margine d’incremento del trasporto merci su ferro in presenza di un servizio ferroviario ottimizzato sarebbe piuttosto limitato (nelle ipotesi più ottimistiche non arriva al 18%) e come tale ottimizzazione prescinda dalla pura velocità dei convogli. Ora prenderemo coscienza con l’ausilio di un Dottorato di Ricerca redatto nel 2001 dal Dottor Mirco Federici appartenente al dipartimento di chimica dell’Università degli Studi di Siena, di come l’impattoambientale, l’inquinamento ed il consumo energetico del TAV non siano per nulla assimilabili a quelli delle ferrovie tradizionali.
Mirco Federici ha operato un confronto fra la tratta ad alta velocità Milano – Napoli e l’equivalente tragitto dell’autostrada del Sole. Nello studio si contabilizza l’intero consumo di energia e di materia e le emissioni associate lungo l’intero ciclo di vita dei sistemi. Si tiene cioè conto dei consumi nella fase di costruzione delle linee stradali e ferroviarie, della manutenzione periodica, della costruzione e manutenzione dei veicoli e del loro funzionamento annuale. Gli impatti sono inoltre stati calcolati utilizzando 6 analisi differenti, le quali conducono tutte a risultati convergenti.
Le conclusioni del confronto, secondo le parole di Mirco Federici, si manifestano quanto mai sorprendenti, in quanto dimostrano come il TAV abbia impatti ambientali superiori al trasporto merci su gomma e addirittura paragonabili al trasporto individuale in auto, inoltre non migliora l’impatto dovuto alle emissioni ed anzi peggiora la qualità ambientale a causa dell’invasività delle sue infrastrutture. Viene sottolineato come risulti inutile ed oltretutto dannoso investire su una tipologia di trasporto che non offre miglioramenti ambientali nel caso del trasporto passeggeri e addirittura peggiora la situazione per quanto concerne il trasporto merci. Si aggiunge inoltre che se questi risultati venissero integrati dagli altri impatti ambientali relativi alla cantierizzazione del TAV, che nello studio non sono stati considerati, come ad esempio le falde acquifere deviate, infiltrazioni e contaminazioni dei terreni e delle falde, inquinamento acustico ed altro ancora, il giudizio finale diverrebbe ancora più negativo.
La causa di una così scarsa competitività delle linee ad alta velocità/capacità rispetto agli altri sistemi di trasporto è da ricercarsi nella troppa infrastrutturizzazione del sistema TAV e nella eccessiva potenza dei treni, sovradimensionati rispetto alla loro capacità di trasporto. Un treno TAV, ad esempio un ETR ha una potenza di 8 MW, il che significa che per muovere un solo treno occorre la potenza di una centrale elettrica di medie dimensioni.
Nelle conclusioni si afferma che se la costruzione delle linee ad alta velocità/capacità dovesse essere giudicata solo per mezzo di criteri termodinamici il verdetto sarebbe di una sua completa inutilità.
Anche dal punto di vista ecologico il TAV non può dunque nutrire alcuna velleità, poiché perfino se l’infrastruttura riuscisse (pur non avendo le caratteristiche per farlo) a spostare su di essa quel 18% di traffico merci che oggi corre su gomma l’effetto sarebbe in tutto e per tutto ecologicamente peggiorativo.
In Val di Susa, se mai lo scellerato progetto oggetto delle contestazioni da parte delle comunità locali andasse in porto, si assisterebbe alla nascita di un nuovo “mostro” dal costo previsto di circa 15 miliardi di euro. Che se la matematica non è un’opinione, attualizzati all’ipotetica data di fine lavori (2025/2030?) aggiunti gli interessi intercalari da pagare alle banche nei prossimi decenni per il denaro preso a prestito e tenuto conto dell’incremento medio di costo, nell’ordine del 300% rispetto alle previsioni, riscontrato finora su tutte le tratte TAV già costruite, porterà l’investimento oltre i 60 miliardi di euro. Sessanta miliardi di euro dei contribuenti italiani, che i cittadini della Valsusa stanno tentando di difendere con le unghie e con i denti, insieme al futuro del territorio in cui vivono.
Marco Cedolin


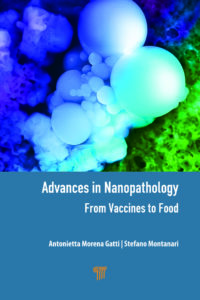
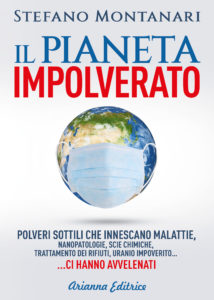
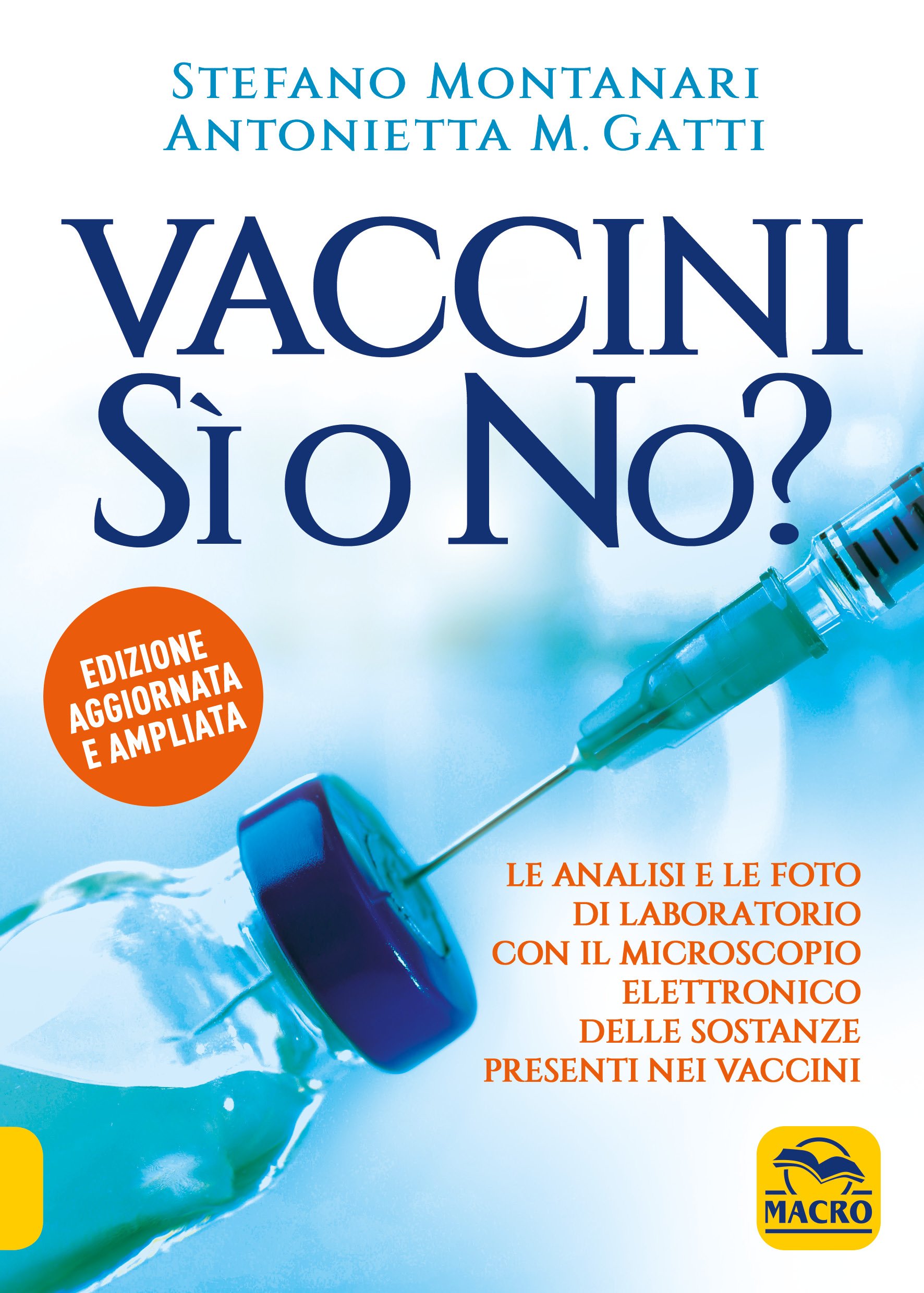
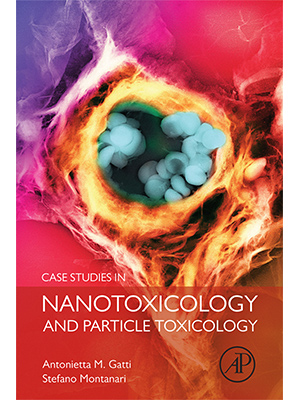
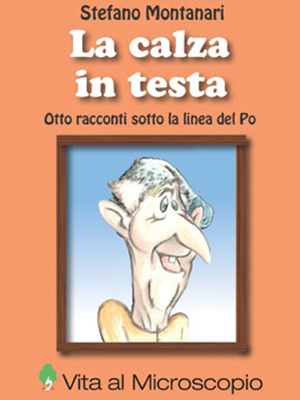
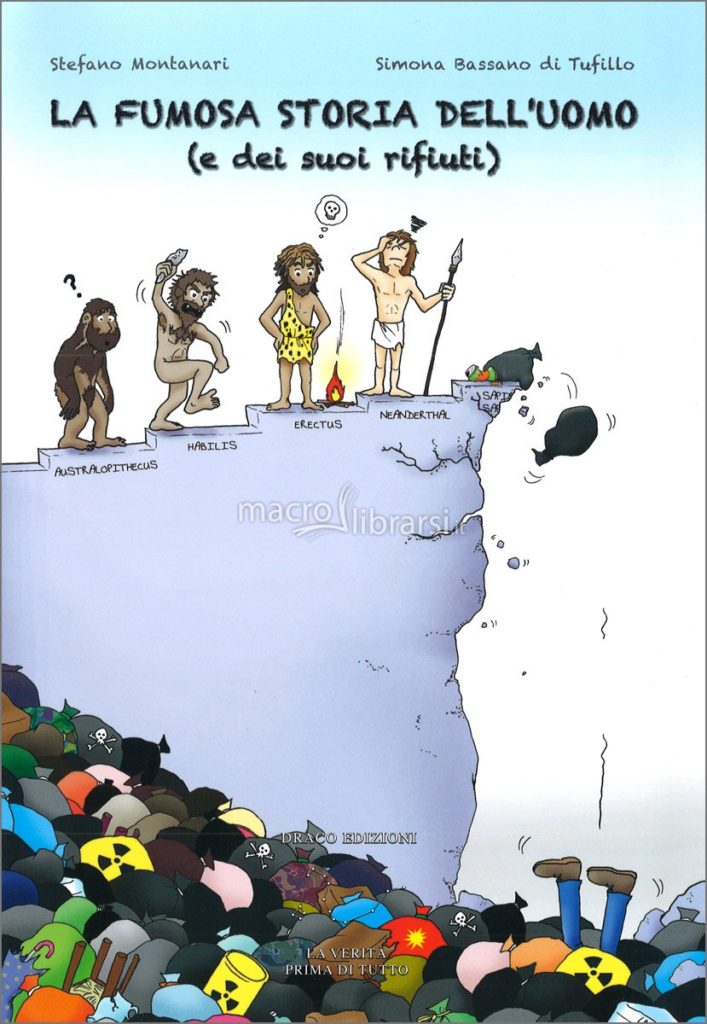
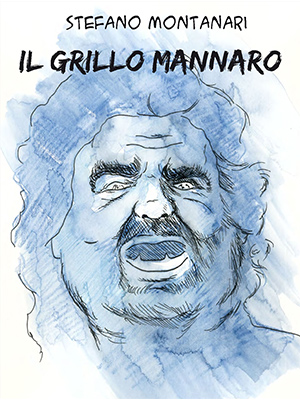
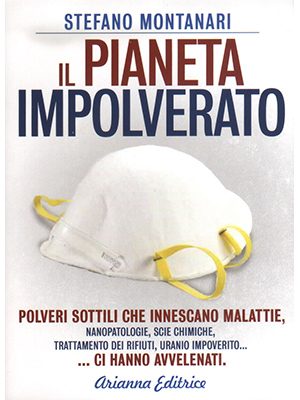
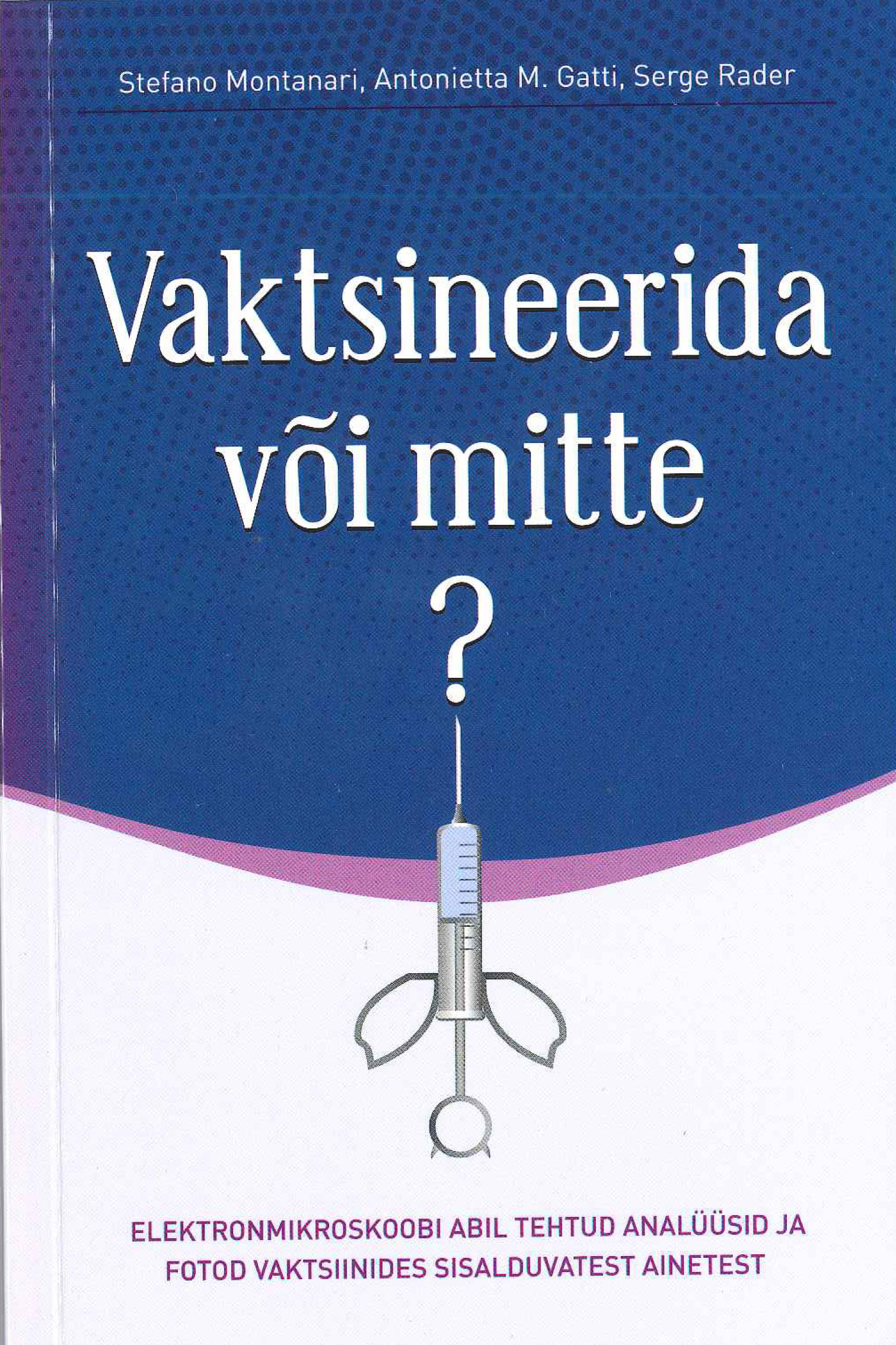
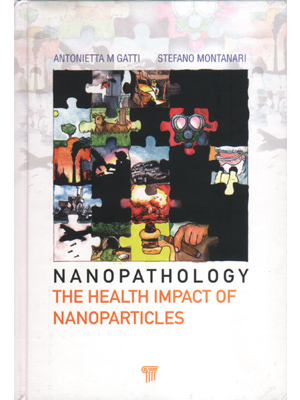
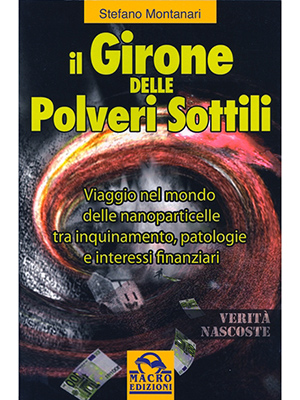
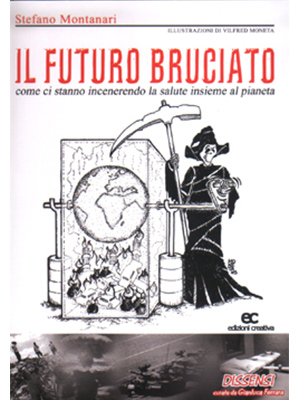
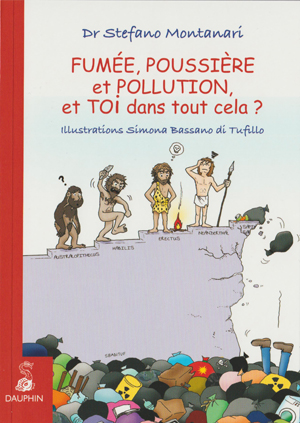
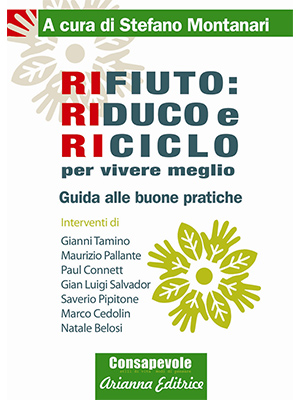
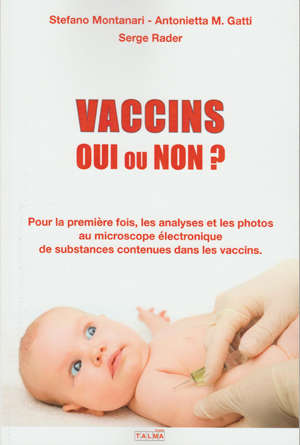
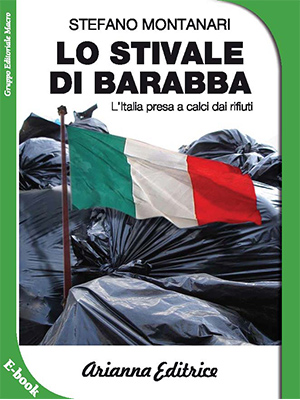
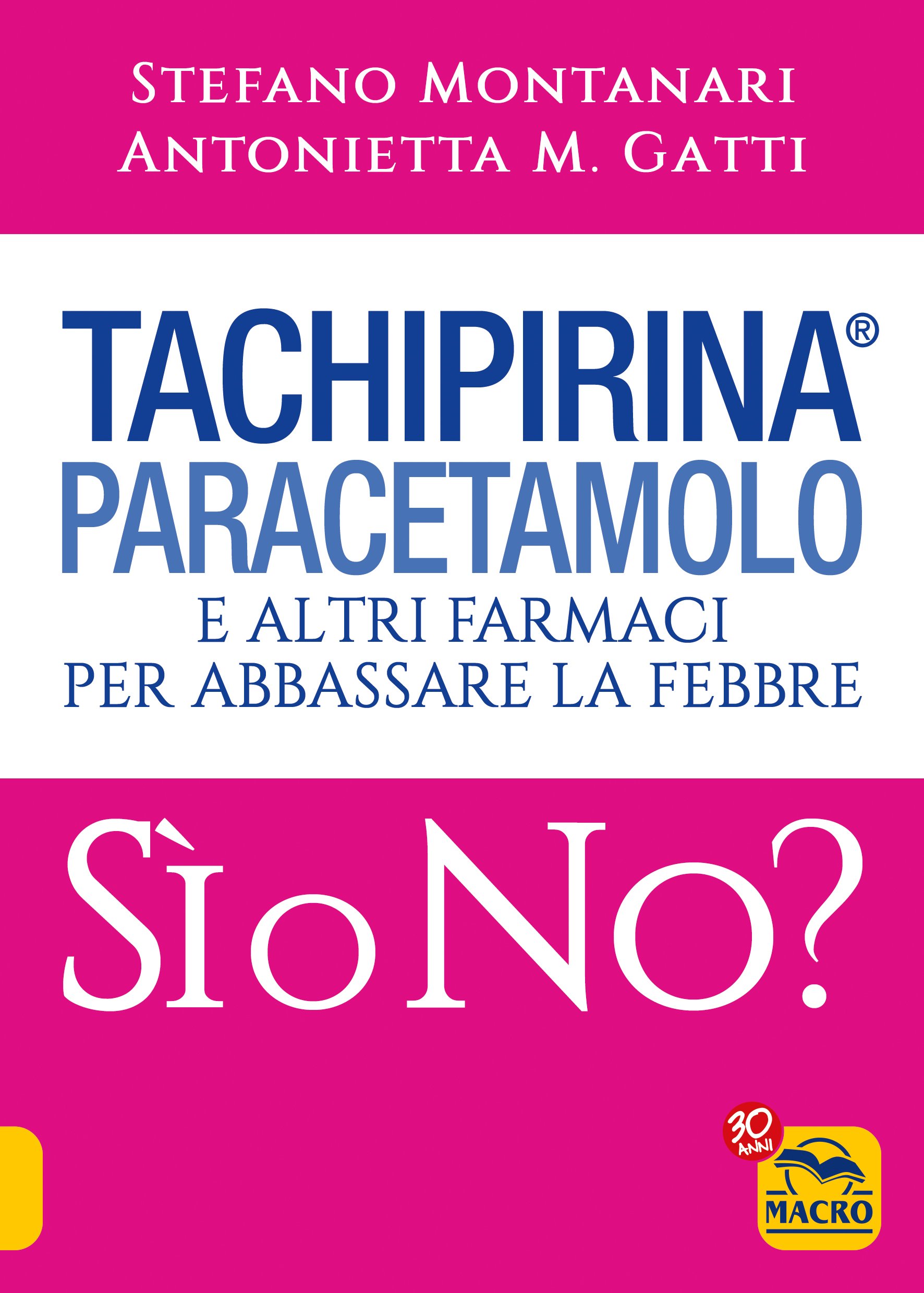
x
Da quando c’è il TAV Firenze-Milano ho smesso di usare il treno per suoi costi proibitivi.
Sono ritornato ad usare l’auto.
In tanti hanno fatto come me.
RISPOSTA
Un consiglio: prima d’imbarcarvi su uno di quei treni, fate pipì. Una volta in viaggio potreste non trovare una “ritirata” (era l’antico nome dei gabinetti ferroviari) funzionante o potreste vomitare entrando in una aperta.
Cose gia’ sentiteSu REPORT ne hanno gia’ parlato ma non solo li, anche il fazioso GRILLO lo ha detto e scritto ovunque.Quanto scritto qui e’ stato detto pari pari gia’ in altre sedi e la gente DOVREBBE oramai aver gia’ capito che la TAV e’ una BASTARDATA infinita, fatta solo per onorare impegni presi con i soliti stramaledetti poteri forti e MAFIOSI.Nonostante questo, ancora trovi persone che infilano commenti dei blog dei giornali piu’ diffusi dewl tenore :”la TAV si dEVE FARE e quei rompiballe non devono lamentarsi SOLO PERCHE’ PERDONO LA CASA” … ! 1)questi delelebrati non hanno MAI… Leggi il resto »