Prendo un po’ di respiro e pubblico un vecchio racconto, sperando che qualche editore si accorga di quanto sono bravo ed allontani da me il calice amarissimo che ingurgito quotidianamente.
“Si fa, ma non si dice” è il titolo di una canzone risalente al 1932 cui, chissà perché, si è voluto attribuire un significato erotico che assolutamente non aveva. In realtà il fatto tenuto nascosto era
nient’altro che lo sfogo gassoso dell’intestino che accomuna il principe al mendico.
Il protagonista del raccontino è esistito davvero. Si tratta di un personaggio che ormai da anni ha lasciato questa valle di lacrime e che non rispondeva al nome fittiziamente attribuitogli nel testo.
SI FA, MA NON SI DICE
Sol si re faaaa. “Lohengrin”, terzo atto, preludio.
Il dottor Ireneo Trippa era un uomo soddisfatto di sé: alla sua settantaquattresima primavera – per usare parole sue – si sentiva nella primavera della vita. Di sé gli piaceva tutto: il fisico asciutto e minuto, le guancine rosee, gli occhietti azzurri, l’eloquio che sentiva essere coltissimo, la fortuna – meritata – nella professione e, soprattutto, il cuore buono che non di rado lo commuoveva. Della sua soddisfazione non faceva mistero; anzi, ne parlava spesso con la moglie – bionda, imponente, di una ventina d’anni più giovane – con il figlio (della prima moglie, buonanima), con il nipote e con chiunque gli capitasse a tiro. Del resto non poteva immaginare che esistesse un argomento più interessante della vita e delle opere di Ireneo Trippa, comasco, dottore commercialista in Milano.
Ma c’era un’abilità di cui non aveva mai fatto parola con nessuno, anche se più di uno ne aveva sospettata, e ne sospettava, l’esistenza, pur non nella sua completezza.
Andandosi a leggere la partitura del “Lohengrin”, a cavallo delle battute sedici e diciassette del terzo atto si trovano, nella parte del corno, le note re, fa diesis, la, do; il fa diesis giustificato dalla tonalità di sol maggiore trasposta di una quinta. Non che il dottor Trippa amasse particolarmente Wagner o avesse mai visto una partitura in vita sua. Il fatto è che poco prima della guerra, trionfatore nei giochi littoriali lombardi di computisteria, aveva vinto un viaggio di tre giorni a Monaco di Baviera, dove aveva acquistato un settantotto giri che riproduceva appunto quel pezzo e se lo era portato a casa a far compagnia a “Giovinezza” e a “Mamma”.
Una mattina del ‘40, avvolto dalla nebbia del lago, si era guardato intorno e, non scorgendo anima viva, aveva lasciato che l’intestino avesse il suo sfogo. Da quello sfintere baciato da Calliope erano sortiti, inconfondibili, intonatissimi, precisamente solfeggiati, un re, un fa diesis, un la e un do scritti per corno, cioè un sol, un si, un re e un fa, eseguiti “sehr lebhaft” proprio come il Maestro voleva. Folgorato, il giovane Ireneo da allora non si era dato tregua e aveva cercato gli angoli più discreti per esercitarsi. E così, provando e riprovando, senza maestro, nutrendosi dei cibi più carminativi che la povera dieta bellica gli consentiva, era riuscito a diventare un vero virtuoso: il sol era un sol, il si un si, il re un re e il fa, vivaddio, un fa. Perfezione a prova di diapason. E tutto quel sacrificio per il mero piacere del risultato personale, ben sapendo che non avrebbe mai potuto esibire la sua abilità. Ora, dopo ben più di mezzo secolo, quelle quattro note continuavano a siglare segretamente i momenti di trionfo – i tanti momenti di trionfo – di una vita ben spesa.
Lo studio Trippa era angusto, straripante di fascicoli tenuti insieme dallo spago, buio. I clienti erano pochi, però erano selezionati. Negli anni, da lì erano passati i più bei portafogli di Milano e il Dottore, saggiamente, si era tenuti quelli ai quali era più facile accedere. Ultimamente stava concedendo la sua assistenza ad un’anziana nobildonna cui il denaro non faceva difetto ma la lucidità sì, e la stava aiutando a disporre in modo opportuno del futuro dei suoi beni nel caso sfortunato, ma, ahimè, probabile, di quella dipartita che i medici davano per imminente.
Abitudinario, il venerdì alle dodici salutava la segretaria, ormai settantenne, ripetendole la raccomandazione di chiudere con cura porta e finestre. Quel venerdì era la vigilia del compleanno di Pericle, il nipotino, e il Dottore, eccitato dalla generosità del regalo che stava per fare, decise di partire a mezzogiorno meno sette. Si sfilò le mezze maniche (le teneva sempre quando non c’erano clienti) e salutò Mariù con un ‘a lunedì’ e basta.
“E le finestre?”
“Le chiuda con cura! E anche la porta!”
Passò a casa a prendere la Signora.
“Hai il regalo?”
“E’ qua,” fece lei, estraendo dalla borsetta un pacchetto da gioielleria.
“Più sono piccoli, più valgono!”
Dopo nemmeno tre ore, la vecchia Mercedes, novello Leonida delle Termopili, a capo di una fila diventata lentissima di una cinquantina di automobili strombazzanti, accostò sul piazzaletto del cancello. Cinquanta screanzati sfilarono gridando, qualcuno anche atteggiando le dita a coppia di corna.
Dalla villetta dei Trippa la vista sul lago era davvero splendida. Tornarci ad ogni fine settimana era un bagno nella fonte dell’Eterna Giovinezza.
Come sempre Adolfo, il custode, portò la gabbia di Omero e la porse alla Signora.
“Cantami o Diva…” gracchiò il merlo indiano.
“E’ proprio vero – disse il Dottore – che gli uccelli non vedenti hanno una voce bellissima. Sei fortunato, uccellino!”
Il dottor Trippa, tenero com’era, non se l’era sentita di pungere gli occhietti di Omero. Così aveva pregato Adolfo di pensarci lui. Ed ora la gracula faceva davvero onore al nome che le avevano imposto.
L’ispezione al giardino era operazione tradizionalmente condotta in solitudine. Non c’era albero, cespuglio o fiore che sfuggisse all’occhio azzurrino del “dominus”. Dominus era una parola che gli piaceva. Il latino non aveva potuto studiarlo ma, come surrogato, si era imparata una bella quantità di parole e anche di sentenze prese da “Il latino per tutti e per ogni occasione” che il suo amico farmacista si era pubblicato a spese proprie.
Da sempre, arrivato davanti all’aiuoletta della salvia, appartatissima, si fermava e, premendosi con delicatezza il ventre (lo strumento non aveva prezzo e richiedeva attenzione), eseguiva la sua sigla musicale.
Quel venerdì, il la gli uscì crescente e, con uno scatto dei glutei, arrestò la performance strabuzzando gli occhi: i fiori rossi di alcune delle piantine di salvia erano appassiti, marroni, con il capino reclinato. Si guardò intorno: gli altri fiori erano belli, bellissimi, semplicemente perfetti. Perché la salvia, la sua amata Salvia splendens (nome scientifico cui va attribuita la prima esse maiuscola, e il dottor Trippa lo sapeva), era malata? S’inginocchiò e accarezzò con delicatezza una corolla scuotendo la testa. Stavano soffrendo?
“Nonno…”
La voce alle spalle lo colse di sorpresa. Pericle stava lì, lungo, brufoloso, emaciato, triste, sempre con quel vago odore di urina. Avrebbero fatto il compleanno tutti insieme, al lago, nella villa del nonno Nino, al secolo Ireneo. Dalla porta uscivano Galeazzo, il figlio, a quarant’anni già pelato e con la pancia pendula da bancario, e Sveva Amalia, la nuora, ultimogenita di una famiglia nobile ormai in disarmo, Pericle in versione femminile, odore compreso. Gli andarono incontro e lo baciarono sulle guance lisce come un sederino di neonato.
Sbrigate le formalità con i parenti e speditili in casa, il dottor Trippa riprese a passeggiare per il giardino. Da una finestra balzò fuori Giampiero, il gatto. (Il nome era quello di Boniperti, vecchio capitano della Juventus, del cui bianco e nero sociale era colorato il mantello del felino.) Gli occhi azzurrini seguirono benevoli l’incedere elegante dell’animale che si soffermava ad esaminare piante e fiori con curioso interesse. Ad un certo punto, flagrante, il delitto: Giampiero mingeva sulla salvia. Ecco la spiegazione, ecco il reo! Il dottor Trippa lanciò un grido: “Assassino!” e il gatto fuggì.
La sera, a letto, il Dottore si voltò verso la Signora, sepolta sotto quaranta centimetri di bigodini e con la faccia intonacata di bianco: “Giampiero fa le sue cose sulla salvia: è lui.”
La Signora, intenerita dal terribile destino cui i fiori non sarebbero scampati, cercò di convincere il marito a liberarsi dell’animale con la pistola che teneva, per ogni evenienza, nel cassetto. Niente. Ireneo aveva un cuore d’oro, lo sapevano tutti, e non avrebbe mai potuto fare una cosa simile. Ma, d’altra parte, mica si potevano lasciar morire così, indifese, le salvie.
Fu una notte di tormento interiore.
La mattina, con le borse sotto gli occhi, il Dottore scese in paese e andò dal suo amico farmacista.
“Ma che te ne fai di una bottiglia di etere?”
“Devo smacchiare un paio di pantaloni.”
“La trielina ci vuole, mica l’etere.”
“La Signora dice etere. Sai come sono le donne…”
Con la bottiglia sotto braccio entrò in cartoleria e ne uscì con un rotolo di nastro adesivo da imballaggio.
Quando a pranzo porse il regalo a Pericle, era un po’ distratto, concentrato com’era sul piano che aveva escogitato e che avrebbe messo in atto di lì a poco.
Per la diciassettesima volta mostrò al nipote il pacchetto e glie lo aprì laboriosamente.
“Vedi, Pericle, questo è un Marengo…”
“Come gli altri,” sussurrò il giovanotto.
“…e t’insegnerà il valore del risparmio.”
Il nonno Nino ripose la moneta tra il cotone nella scatoletta che s’infilò subito in tasca.
“Questa starà nella cassaforte del nonno e, quando ne avrai bisogno, saprai dove venirla a prendere.”
Trattenendo il respiro, il Dottore cercò accuratamente un punto della fronte di Pericle dove i foruncoli fossero meno maturi, e lì lo baciò.
Un calcio di Sveva fece uscire un ‘Grazie, nonno.’
Liberatosi finalmente degli ospiti, il dottor Trippa uscì a cercare Giampiero.
Era lì, immobile, in agguato vicino alle sue vittime ormai stremate dai quotidiani marchi territoriali.
L’uomo si avvicinò con aria indifferente.
Il gatto si allontanò annoiato.
Ancora qualche passo di avvicinamento.
Un balzo sul melo.
“Prova tu,” disse il Dottore alla Signora, rientrando in casa innervosito.
Questa uscì e si sedette sulla panca davanti alla porta con una salsiccia in mano.
Giampiero non si fece pregare e saltò in grembo alla donna, addentando la carne che questa non mollava.
Intanto il Dottore si avvicinava quatto quatto con uno scatolone vuoto sotto braccio.
La Signora accarezzò il micio e, lisciandolo, gli strinse la pelle alla collottola. In un attimo il gatto fu imprigionato nella scatola, lestamente chiusa e sigillata.
“Dentro è piena di cotone imbevuto di etere,” fece lui, ottenendo un cenno d’approvazione dalla moglie.
In un angolo appartato del giardino – un ambiente ideale da concerto – il dottor Trippa, solo, scavò una buca mentre lo scatolone si agitava sempre più piano.
In breve la terra coprì tutto. Re fa la dooo.
Forse si era ancora in tempo a salvare le povere labiate.
La sera, a cena, i due sapevano di essere buoni. A costo di sacrifici (l’acquisto dell’etere e del nastro, la cattura del reo, lo scavo della fossa) avevano fatto il loro dovere. Potevano dormire i sonni del giusto.
La mattina, la Signora spalancò la finestra. Il lago era ancora in ombra ma le montagne erano morbide di rugiada e di sole radente. L’aria pungeva, satura di verde.
Da sotto le coperte il dottor Ireneo Trippa, baciato dalla prima luce, pregustò il piacere trepido di vedere risorgere le piantine per la cui salvezza tanto aveva fatto. L’intestino straripava di energia.
Scesero le scale tutti e due, insieme, per mano come non facevano da anni, e spalancarono la porta che dava sul giardino.
Giampiero, seduto sulla panca, con le zampe arrossate di sangue, li guardò entrambi ed emise, tonanti, perfettamente intonate, per niente feline, le quattro note del “Lohengrin”.


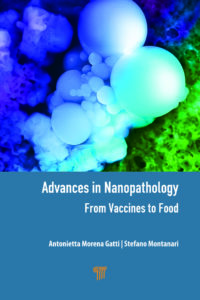

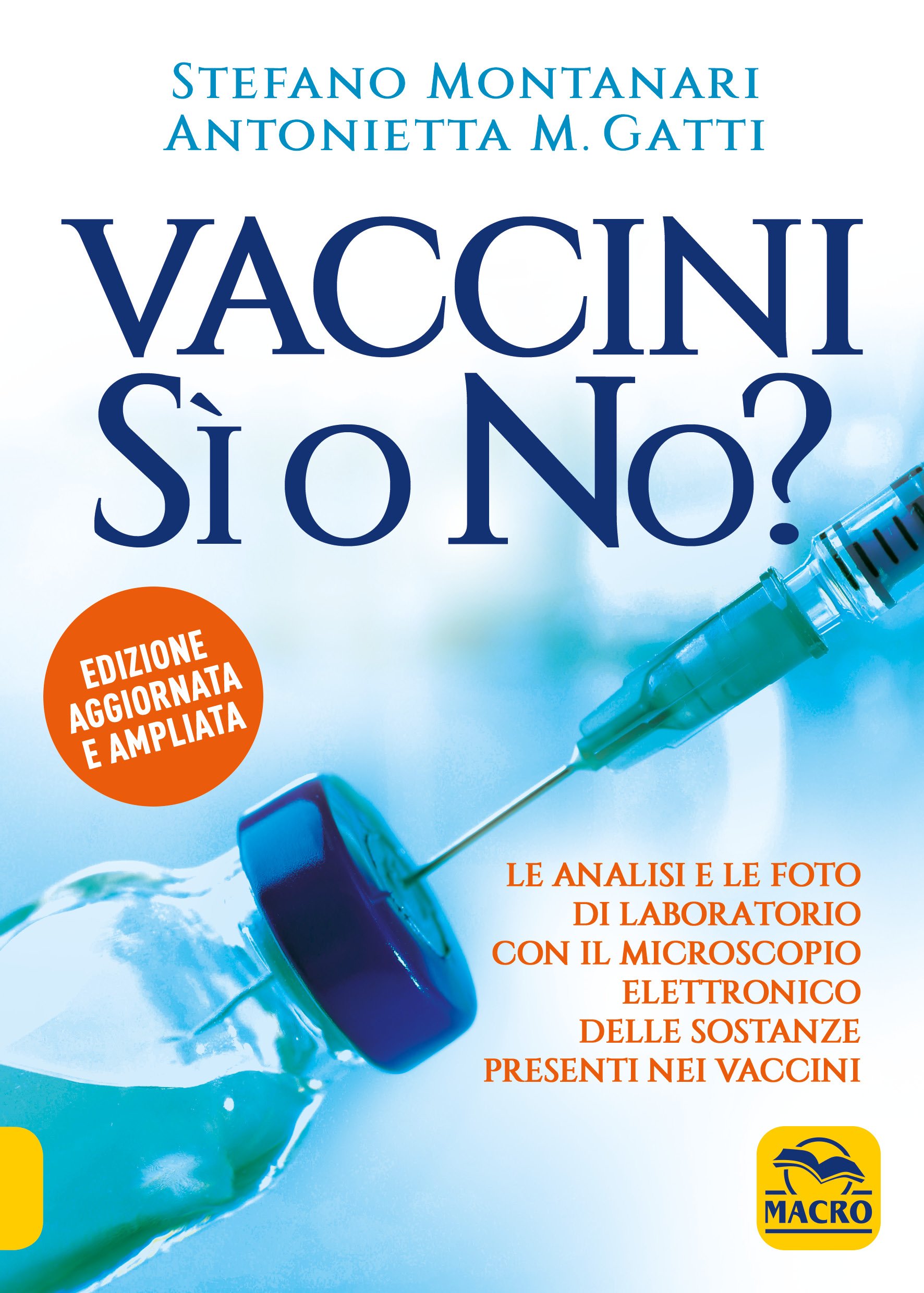
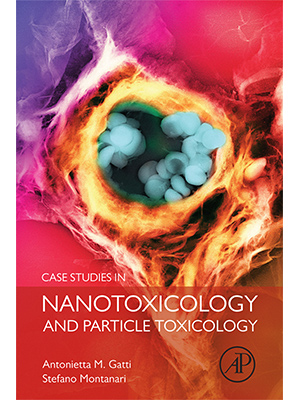




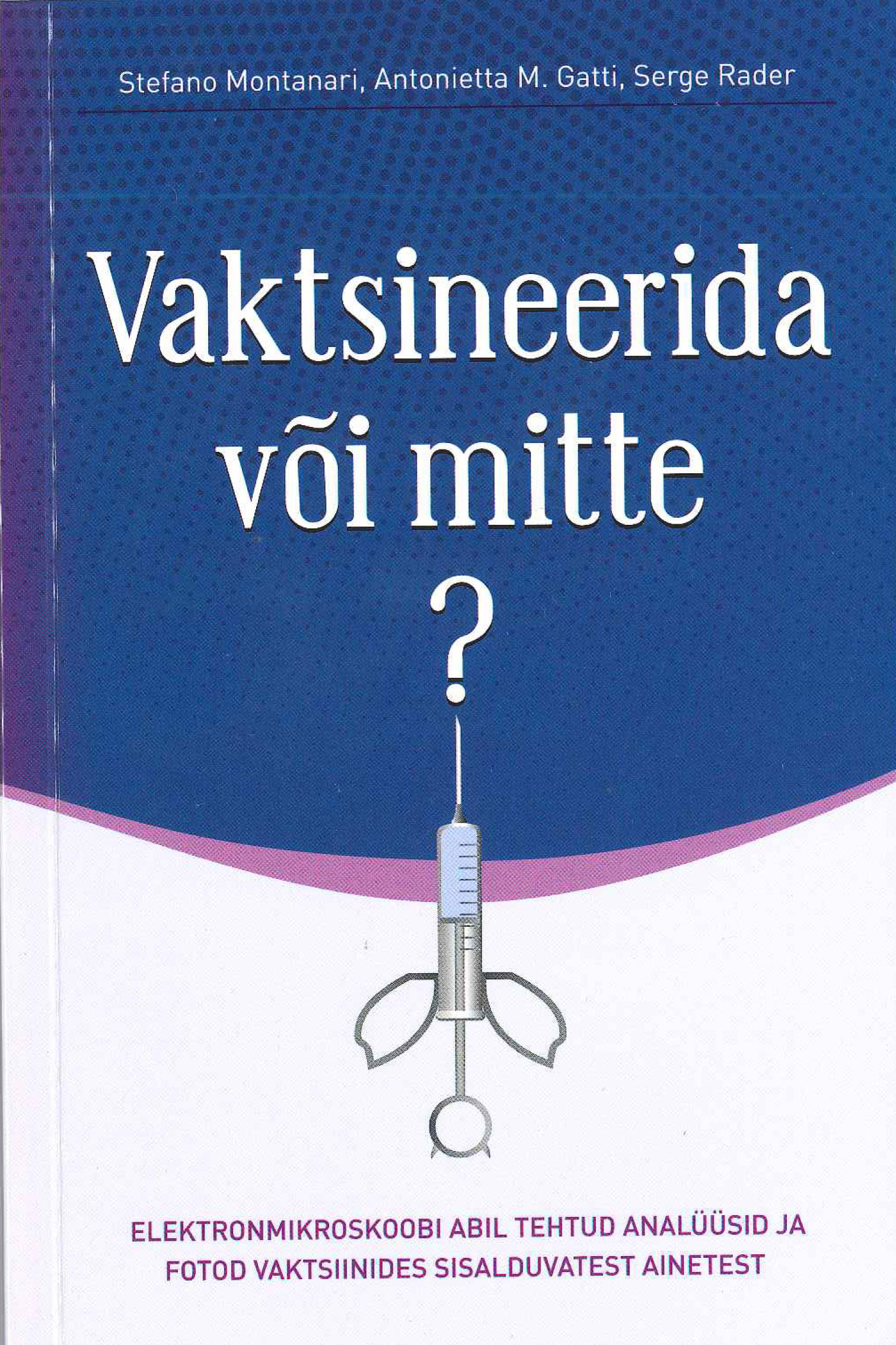
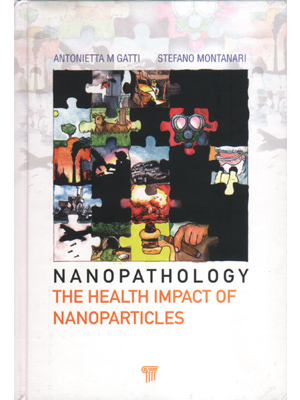




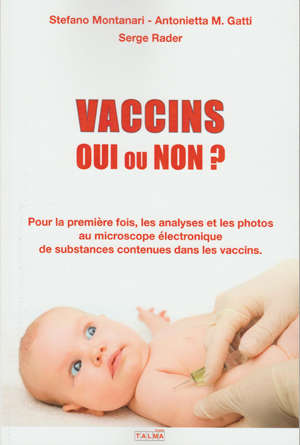


….my God
…..mi fanno male le ganasce ! 😆
RISPOSTA
Vede? Avrei dovuto fare altro.