Per millenni la scienza è stata semplicemente l’espressione di esperienze confermate dall’univocità dei risultati pratici, vale a dire da previsioni azzeccate. I primi scienziati etichettabili come tali furono probabilmente gli astronomi, capaci di registrare il moto apparente dei corpi celesti e di prevedere con grandissima precisione eventi anche lontani nel tempo che al moto di quei corpi si legassero. Quella era scienza pura, cioè conoscenza senza ricadute tecnologiche, quelle ricadute oggi sempre più frequenti e desiderate che della scienza sono solo figlie non sempre legittime.
Poi arrivò la filosofia e, in un certo modo, quella disciplina prese il sopravvento sull’osservazione, tanto da relegare quest’ultima a qualcosa di volgare. L’esperimento era visto come una violenza fatta alla Natura e, dunque, quasi per educazione, si sceglieva di trovare la “verità” con la sola forza del ragionamento, un ragionamento che non sempre coincideva con la ragione. Ecco, allora, le illazioni più curiose “dimostrate” a filo di logica, e per più o meno un paio di millenni si andò avanti su quei binari. Poi, a cavallo tra Cinque- e Seicento, arrivarono i grandi filosofi della scienza, da Bacone a Galileo a Cartesio, con l’idea che le chiacchiere, per eleganti che fossero, non bastassero più e con l’idea immediatamente conseguente che, per ragionare di scienza, occorressero dati empirici, il che significa dati basati sull’esperienza. A questo punto diventava indispensabile abbattere castelli di stramberie ormai incrostate stabilmente nella cultura e non credo ci si possa sorprendere se questa ovvietà non abbia incontrato particolare simpatia fra i tromboni del tempo. Magari un po’ di sorpresa potrebbe esserci se si pensa che ancora oggi, a distanza di qualche secolo, all’aggettivo “empirico”, a dispetto della sua nobiltà, si affibbia correntemente un alone dispregiativo.
Per avere un’idea dell’atteggiamento di “chi conta”: a metà Ottocento un grande medico come Rudolf Virchow, nemico giurato di Louis Pasteur che aveva il difetto terribile di non essere medico ma chimico, si vantava di non aver mai accostato l’occhio ad un microscopio. A XXI secolo ormai inoltrato la situazione non è cambiata di molto. Forse si è perfino aggravata.
Ancora oggi non si attribuisce importanza e valore a ciò che viene affermato quanto a chi afferma. In breve, se una verità esce da un signor Nessuno, quella non può essere verità. L’opposto avviene se l’affermazione è il parto di qualcuno che, a ragione o a torto, è reputato uomo di scienza degno di fede.
E qui sta un inghippo enorme. Costruire un’immagine non è poi troppo difficile e di scienziati di cartapesta ne abbiamo a iosa, il che sfocia inevitabilmente in parti distocici di rampolli deformi. Il brutto è che quei mostriciattoli diventano modelli di bellezza con tutto quanto ne consegue. Chi ricorda le stramberie di un ottimo businessman spacciato convenientemente per grande oncologo che sosteneva quanto fosse innocuo l’inquinamento atmosferico e quanto fosse altrettanto innocuo dormire su scorie di centrale atomica ne avrà contezza.
A peggiorare le cose ci si mettono d’impegno i burocrati. Questa genìa nata migliaia di anni fa dal bisogno tutto pratico di tenere ordine in un’amministrazione statale via via più raffinata si è modificata con gli anni a tal punto da fornire un pesante contributo al cattivo andamento del mondo sociale. Ora costoro, in non pochi casi veri e propri imbecilli, vestono addirittura i panni dello scienziato e si palleggiano allegramente, perpetuandole, stravaganze prive del minimo fondamento. Malauguratamente la pigrizia di tanta parte della popolazione fa sì che vere e proprie assurdità vengano correntemente accettate come verità scientifiche indiscutibili, fino ad arrivare ai legislatori impegnati a costruirci sopra le loro regole.
Giusto per dare un esempio di quello che dico, prendiamo il valore legalmente insuperabile (poi qua e là quotidianamente o quasi superato senza fare una piega, ma questo è un altro discorso) di 40 microgrammi di PM10 in un Normal metro cubo di aria. Perché PM10? Ma, soprattutto, da dove viene quel numeretto? Le risposte sono che PM10 era il tipo di polveri che le macchinette di controllo meno costose erano più o meno capaci di rilevare e 40 era una pia invenzione perché un valore bisognava pur darlo e, allora, in mancanza di dati reali, tanto valeva inventarlo. E così fu. Appena a margine, chi ne ha voglia si vada a leggere che cosa scrive fuori di burocrazia l’EEA, cioè l’ente ambientale europeo, al proposito: “For PM, no safe level has been identified.”(Report 2/2007). Tradotto significa che per le particelle (e non si fa differenza se si tratta di PM10 o di altre varietà di polveri) non è stato identificato alcun livello di sicurezza. Insomma, fanno tutte male. Ma il legislatore si era espresso e, dunque, PM10 e 40 microgrammi siano e il tutto diventi scienza. Se, poi, si sottilizza un po’, si vedrà che da una parte si parla di massa di PM10 e dall’altra, cioè da quella delle centraline così spesso ingenuamente invocate dai comitati ambientalisti, non la massa ma il peso dell’inquinante polveroso viene valutato, in questo modo spalancando enormi scappatoie tanto grossolane quanto furbescamente funzionali ad aggeggi grotteschi come i filtri antiparticolato obbligatori (!) per i motori Diesel.
Promettendo a chi pazientemente mi ha letto fino qui di non andare oltre, un altro numeretto nato dal nulla è quello relativo alle fibre d’amianto presenti nell’acqua. Quante ce ne possono essere in un litro perché noi possiamo berla e cuocerci gli spaghetti in tutta tranquillità? E chi lo sa? Il nostro ineffabile Istituto superiore di sanità, interpellato, non ne ha la più pallida idea, ma qualcosa deve pure dire, perché le tre parole “non lo so” non fanno parte degli usi e costumi. Così i burocrati che in quell’ambito tirano le quattro paghe per il lesso di carducciana memoria vanno a vedere che cosa dicono “gli americani”, da sempre considerati qualche spanna sopra al mondo intero fino ad essere ascoltati alla stregua di oracoli veri e propri. E “gli americani” sparano: 7 milioni di fibre per litro d’acqua. Naturalmente non è dato sapere da dove prendano quel valore, ma tant’è. Così, oggi negli acquedotti italiani brillantemente costruiti con quell’amianto santificato qualche decennio fa da tanti medici con l’inchino e ora fuori legge per i disastri sanitari prevedibili se non altro perché dell’amianto e dalla sua criminalità sappiamo da una ventina di secoli, possono tranquillamente correre 7 milioni di fibre meno una senza che si perda il sonno. Peccato che si rischi di perdere la salute. I burosauri USA e i loro lacchè italioti non hanno pensato che l’acqua si beve tutti i giorni, che tutti i giorni ci si fanno bollire tagliatelle e spinaci e che, per evidenti motivi, l’amianto, per poco che sia, si accumula giorno dopo giorno. In definitiva, piaccia o no, il valore da non superare è semplicemente zero.
Non do altri esempi, pur se potrei elencarne per diverse pagine, per non annoiare ancor di più i miei pur pochissimi, pazientissimi e volenterosissimi lettori. Dico solo che degli scienziati da avanspettacolo faremmo volentieri a meno.


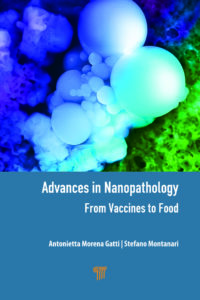
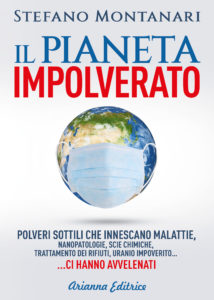
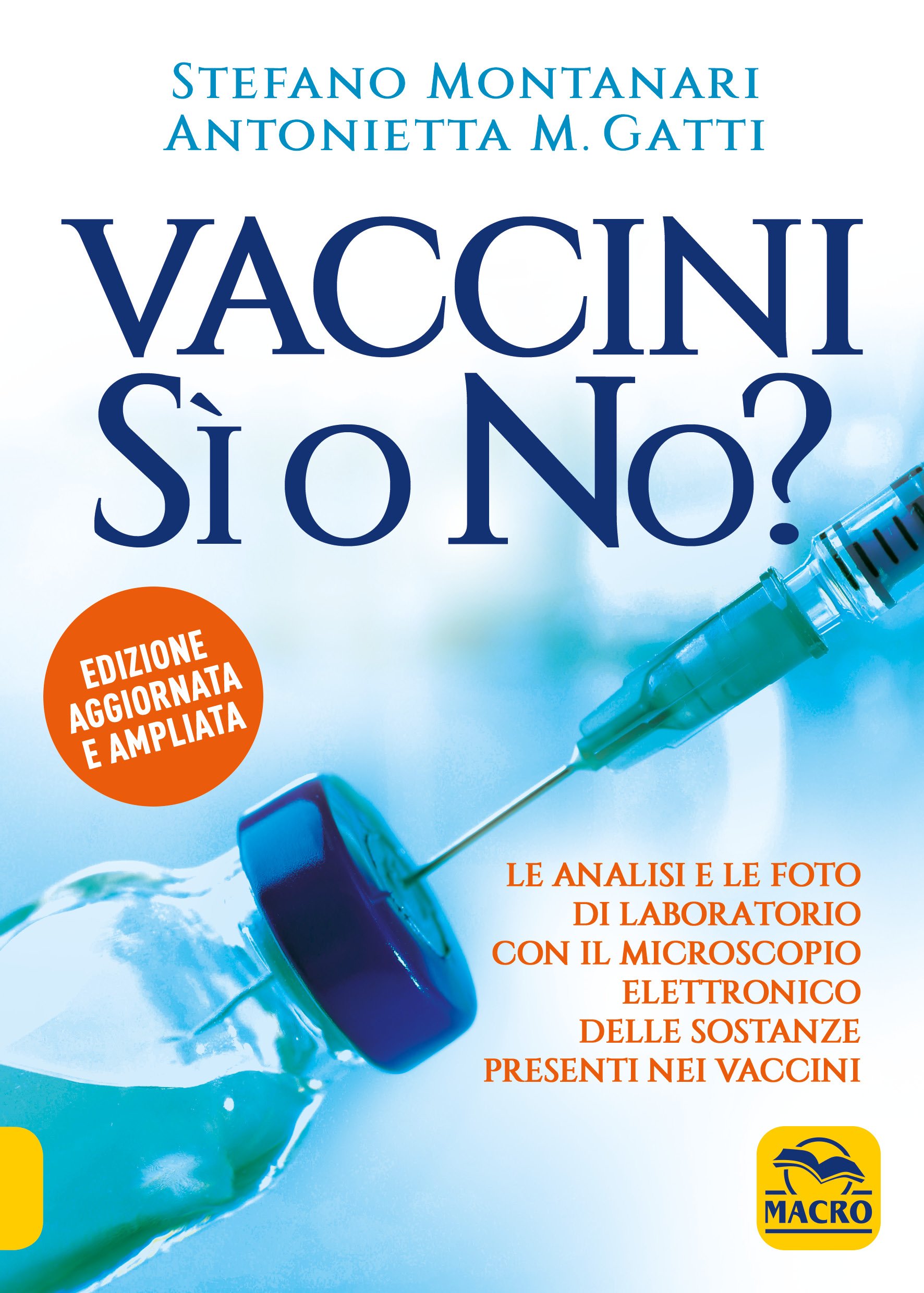
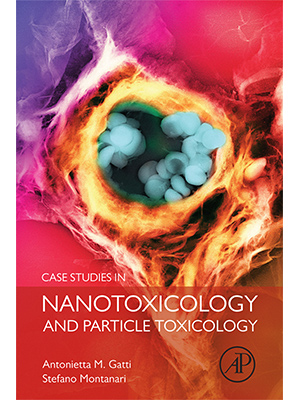
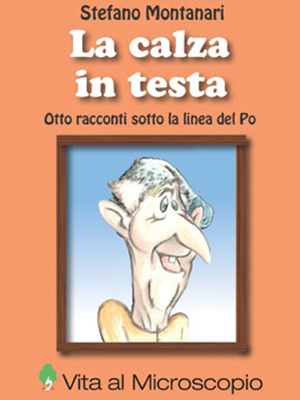
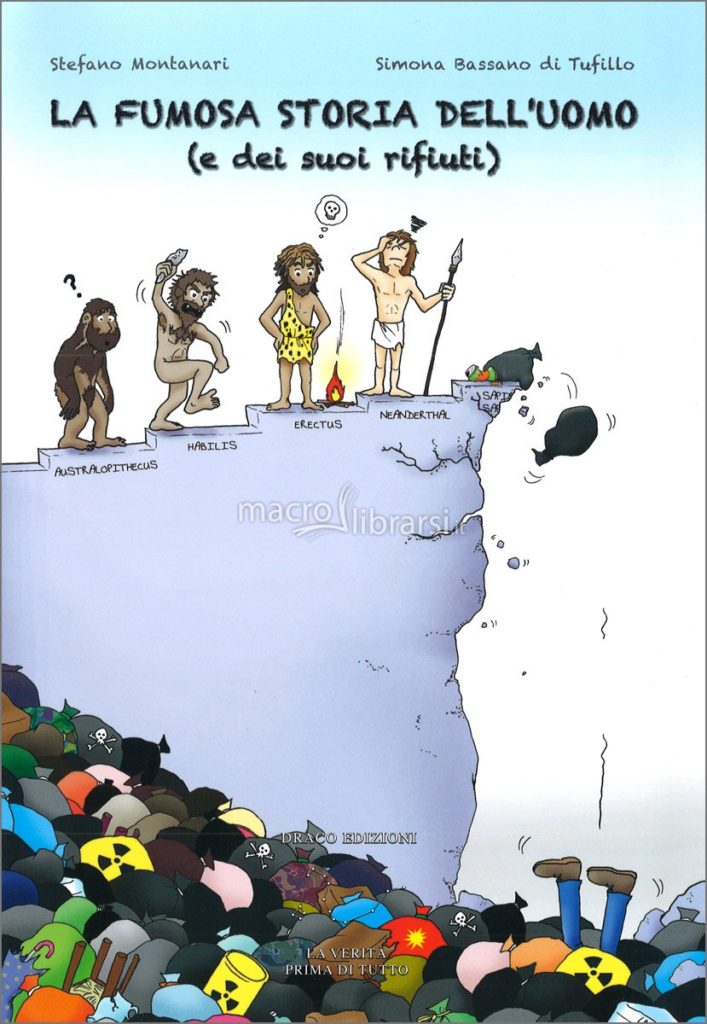
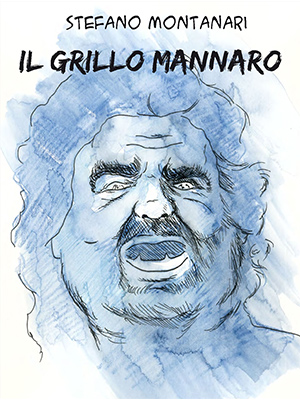
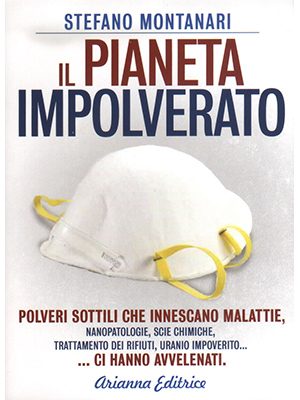
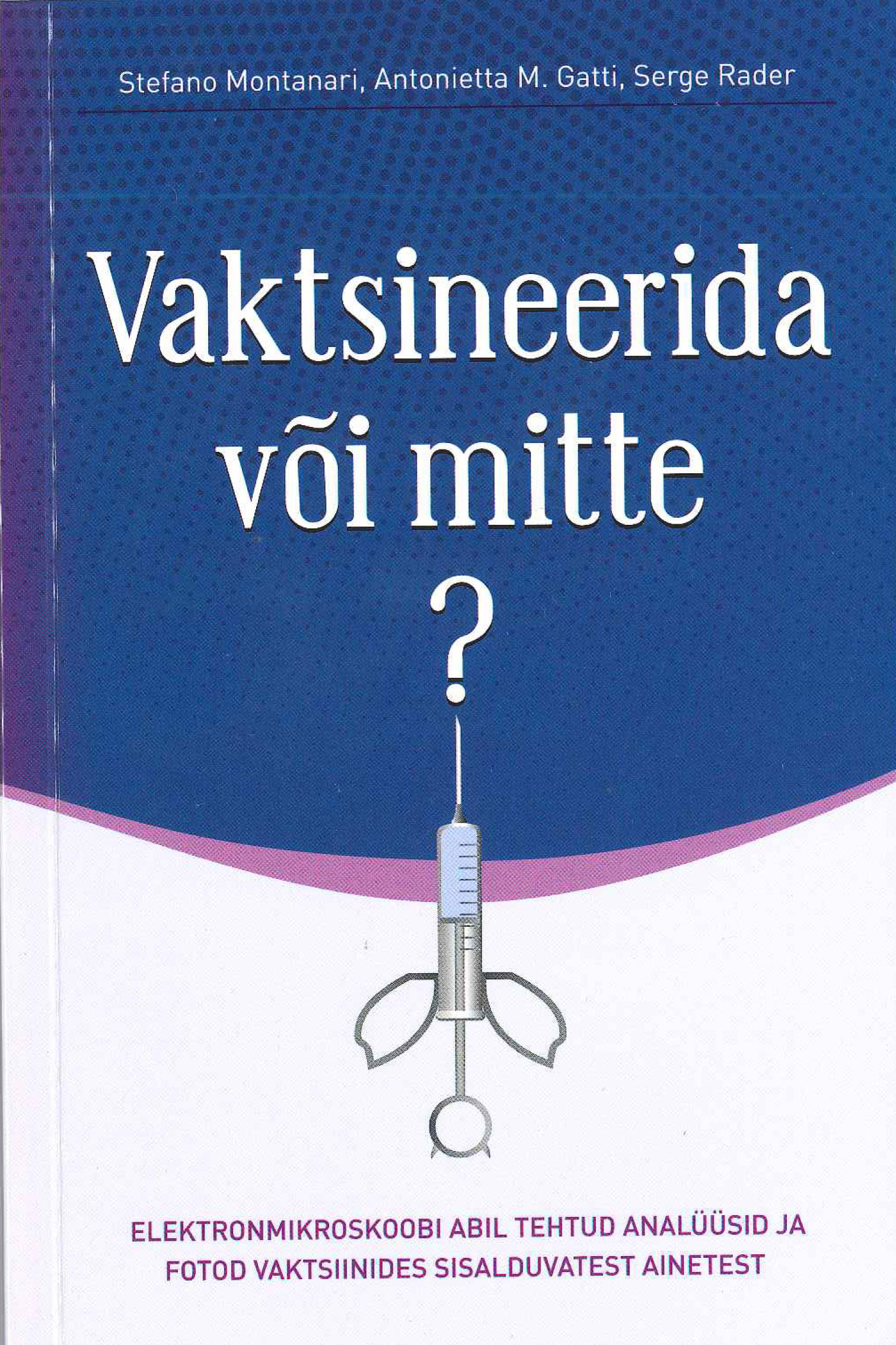
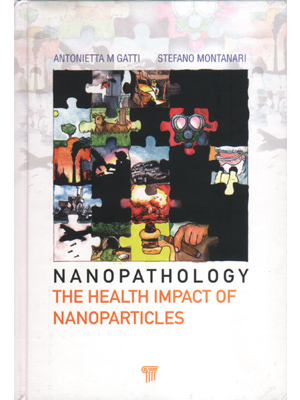
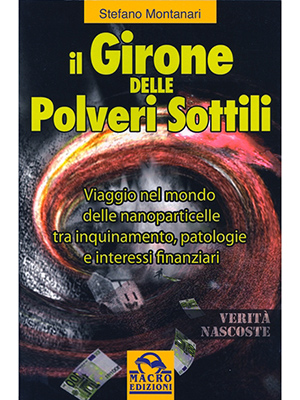
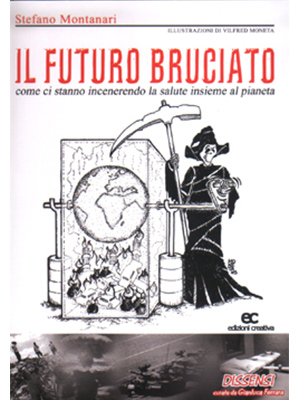
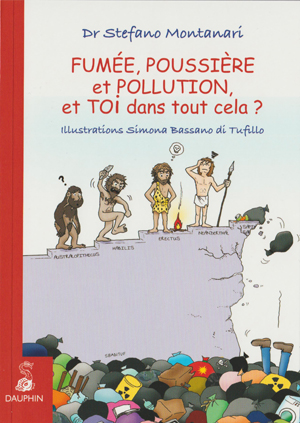
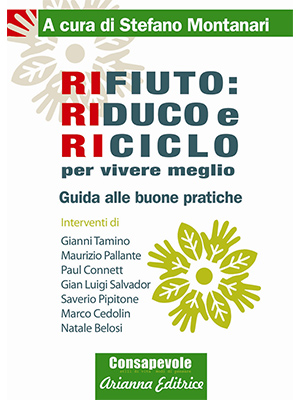
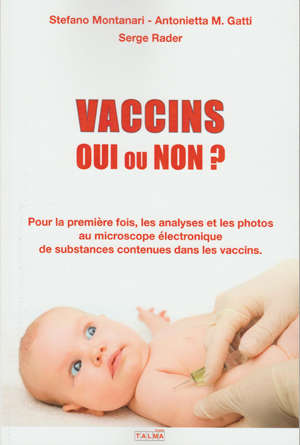
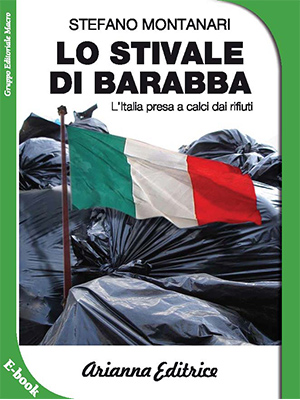
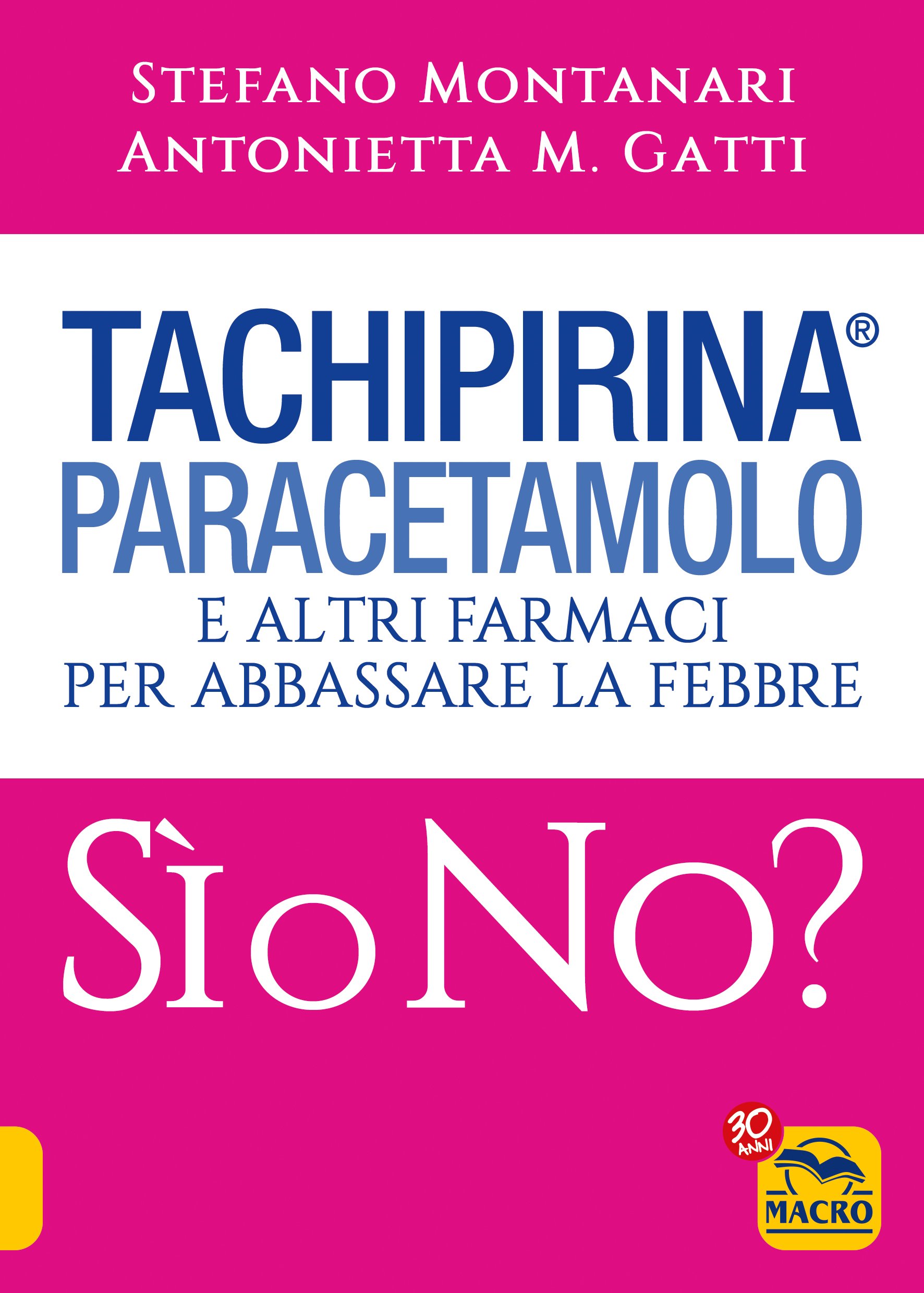
Le polveri e l’amianto dei burosauriCaro dott. Montanari,a proposito di quantità PM10 e fibre d’amianto, vuole un parallelo in economia di una pari menzogna spacciata per verità indiscutibile che, invece, sta mettendo alla fame e nella disperazione milioni di persone?Persone ridotte in uno stato d’ipnosi collettiva che non hanno più nemmeno la curiosità di chiedersi il “perchè” delle cose più banali.E’ legge dello Stato italiano (messo in Costituzione con un colpo di mano degno di un vero golp) che il deficit annuale non debba superare il 3% del Pil.Peccato che nessuno si sia mai chiesto, e tutt’ora non si chieda,… Leggi il resto »