Lo so che v’interessa altro ma abbiate pazienza: tutto a suo tempo.
Per ora, accontentatevi del Montanari hobbista:
I TARLI
Appena aprì lo sportello l’automobile fu invasa da un odore aspro che gli fece perdere per un istante il contatto con le cose intorno a lui. Allora tornò ad essere Lenny. Cercò in fretta di scrollarsi di dosso la sensazione, ma quando riuscì a guardare oltre il parabrezza vide ciò che aveva visto Lenny.
Maurizio era arrivato alla Colombara dopo poco più di un’ora di viaggio, aveva fermato l’automobile sull’aia e, dopo un attimo durante il quale notò che porta e finestre erano nuove, un ragazzo era uscito a prendergli la valigia. Il padrone non c’era, ma la stanza gli era già stata assegnata: al primo piano, eppure già sotto le travi del tetto. Mentre riponeva le sue cose nell’armadio e nel cassettone, respirava l’aglio e il rosmarino che in cucina stavano pestando con il sale grosso.
Aprì la finestra: l’odore era quello che lo aveva accolto. Maurizio voltò le spalle alle colline e cercò un punto scuro nella stanza, un punto sul quale concentrare gli occhi per raccogliere la mente. Essere lì, ma non vedere niente per abituarcisi a poco a poco. Tanti anni erano passati, le circostanze non erano più quelle, il tempo aveva rimodellato gli avvenimenti. Le colline – le aveva viste – erano le stesse, il cielo era dell’identico blu e le nuvole ripetevano le forme sfilacciate di allora. Come sempre la natura rimaneva testardamente indifferente.
Scese nello stanzone d’ingresso che fungeva da sala di ricevimento. Era ancora troppo presto per la cena, così uscì sull’aia e s’incamminò per la strada sterrata, in senso opposto a quello da cui era venuto. Tra due colline rotonde, in basso, correva ancora il torrente. A sud le montagne più alte avevano perso l’azzurro che hanno viste dalla pianura, ed erano verdi e grigie come allora.
Maurizio decise che non doveva lasciarsi ipnotizzare da quella parte della sua mente che, in fondo, aveva sempre ubbidito ai suoi voleri.
La sera si va a letto presto, in campagna. I tarli scavavano il legno delle travi. Di giorno non li senti perché la luce ti distrae, gli uomini si muovono, il pensiero è impegnato a far sopravvivere il corpo. Ma di notte i tarli fanno rumore. Sono lenti, cocciuti, inarrestabili e, piano piano, senza fretta, non lasciano che miseri relitti: gli avanzi di un processo lento e naturalmente giusto. Un processo.
A cena si era fatta vedere soltanto la ragazza che lo aveva servito. C’era lui come unico ospite alla Colombara. Del resto aprile è un mese nel quale ben pochi possono permettersi di andare in vacanza e anche per Maurizio si trattava della prima volta. Pure se era ormai in pensione da qualche anno, vacanze ne prendeva poche, e quelle poche sempre in agosto, com’era abituato a fare quando lavorava. ‘Ma perché – si era detto qualche giorno prima – devo continuare ad andare in agosto se posso permettermi di andare quando ne ho voglia? Anche due o tre volte l’anno, se mi va.’ Maurizio non era sposato e problemi di soldi non ne aveva: pur senza essere un uomo ricco, non gli mancava nulla e tempo… quello ne aveva da vendere, se il tempo si potesse vendere e qualcuno volesse comprare il suo. Così aveva telefonato alla Colombara e aveva prenotato una stanza per due settimane.
Ora, steso sul globoso materasso di lana, con quell’odore cui continuava a prestare coscienza, con i tarli che gli scricchiolavano sopra la testa, si sentiva a disagio e si pentiva di aver deciso capricciosamente quella vacanza. Due settimane, poi!
D’un tratto si accorse che la luna, filtrata dagli alberi della Colombara, scriveva sul muro. Si alzò precipitosamente a chiudere le imposte: chiunque, entrando, avrebbe potuto leggere. Si sedette sul letto: nessuno poteva entrare, e la luna non scriveva un bel niente. Doveva impossessarsi di nuovo, appieno, della sua razionalità.
Erano passati anni, decenni; tante cose si erano succedute; la sua vita aveva preso chi ricorda più quante svolte, molte imprevedibili; era maturato, invecchiato; la prova dei fatti lo aveva costretto a sconfessare sé stesso; si era ufficialmente processato, e aveva impiegato tempo, e si era fatto male. Si era condannato e sùbito perdonato. Certo non l’avrebbe fatto più. Eppure era bastata una zaffata di alberi in fiore, di erba verde, di terra umida; erano bastate le curve bianche del torrente tra le due colline rotonde perché tra Maurizio e Lenny non si frapponesse nulla. Era bastato questo perché tutto venisse rimesso in discussione, anche l’angoscia che aveva provata, anche la cicatrice nell’anima che ne testimoniava la macchia. Era necessario, assolutamente necessario per non perdersi, riprendere l’abito razionale che aveva conquistato con tanta fatica. Lenny era morto da un pezzo.
Come fu un’ora decente, scese a colazione. Lo stanzone era deserto. Aprì la porta sull’aia: quell’odore… Richiuse di scatto e si sedette sulla poltrona cercando di leggere una rivista che stava impilata tra le altre sul tavolino.
“Buongiorno.”
Maurizio trasalì. Dietro di lui era comparso un uomo grosso, con pochi capelli, che gli sorrideva: “Sono il proprietario della Colombara. Mi scusi se ieri non ero ad accoglierla, ma sono dovuto scendere in città per sbrigare un po’ di burocrazia. Spero si troverà bene da noi. Non è stagione, sa, e il personale è ridotto. Adesso siamo solo mia moglie, i miei figli e io. Per qualsiasi cosa, sono a sua disposizione.” Gli tese la mano. Maurizio vi pose la sua, affusolata, ossuta, umida quanto l’altra era tozza, ruvida, calda. L’uomo, sempre continuando a sorridere, uscì sull’aia lasciando entrare l’odore.
In un luogo simile si può passeggiare, si può leggere, si può meditare.
Infilatesi le pedule acquistate per l’occasione, Maurizio s’incamminò. Dopo due o tre svolte si sorprese rendendosi conto che non aveva bisogno di fare alcuno sforzo di memoria per muoversi tra i campi. Anche le case erano sempre le stesse, forse appena invecchiate dai rampicanti che ne ricoprivano i muri: nessuno aveva costruito; nessuno se l’era sentita di andare a spendere la propria vita tra quelle colline. Nessuno che non ci vivesse già, e prima di loro i loro padri. Quelli che erano stati risparmiati. Si rese conto che tutto era restato nitido nella sua mente, pronto a dispiegarglisi davanti non appena avesse abbassato la guardia. Nulla era più netto di quel ricordo. Gli saltò in mente che il cervello non è poi diverso dalla centrifuga del suo vecchio laboratorio: hai un bel da rimescolare le tue polveri, fossero anche cento. Basta farle girare per un po’ e queste si dispongono in bell’ordine, a strati ben differenziati, dalla più densa alla più leggera. Anche le polveri macinate dalla mente fanno così, se le metti nella macchina giusta.
Seduto al suo tavolo, a cena, Maurizio sentiva lo sguardo dell’Uomo Grosso sulla nuca. Quando era entrato, quello gli aveva sorriso, poi aveva continuato a scrivere; ma la nuca formicolava e non osava voltarsi. Intorno a lui altri tavoli erano occupati: la sera qualcuno veniva per mangiare alla campagnola e la presenza di estranei con il loro vociare un po’ lo infastidiva e un po’ lo confortava.
La notte non si decideva a passare: il materasso tutto gobbe, la luna che graffiava, i tarli infaticabili che ticchettavano come mille macchine per scrivere. Per scrivergli sulla fronte. Non c’era ragione per restare tutte le due settimane. Avrebbe pagato il suo conto e se ne sarebbe andato. L’indomani mattina. Il più presto possibile. Benché abitasse a poco più di un’ora di viaggio da quel luogo, non ci aveva mai messo piede. Non ci aveva più messo piede. E questo perché non lo desiderava. In fondo nessuno lo costringeva a restare. La partita con quelle colline, con la Colombara, con il portico della stalla, con l’aia, era chiusa. Basta: non c’era ragione di riaprire un processo passato in giudicato, tanto più quando si era già condannato e non aveva mai chiesto a sé stesso, il suo giudice, di rivedere il giudizio. Lui sapeva bene quanto dolore e quanta fatica aveva speso per giustiziare Lenny.
Prima che albeggiasse cominciò a tirare un vento furibondo, poi il cielo si ruppe in una pioggia che martellava i tetti facendo tacere i tarli e schiaffeggiava la finestra da cui aveva cancellato la luna. Appena fece chiaro, con la valigia pronta posata sul cassettone, uscì dalla stanza. “E’ franata la strada,” sentiva che la ragazza diceva al telefono. La luce della lampadina andava e veniva.
“Per il momento non è possibile percorrere la strada, – disse l’Uomo Grosso quando Maurizio si credette in dovere d’inventare una scusa per tornarsene a casa – mi dispiace: temo proprio che siamo isolati.”
La pioggia non ne voleva sapere non solo di smettere, ma di calare un po’ d’intensità. L’elettricità era stata tolta e la ragazza aveva acceso le lampade a petrolio. Quelle di allora.
In situazioni del genere la Colombara non offriva gran che. A Maurizio non restava che rimanersene in camera a spiare la pioggia e le colline che le nuvole nascondevano e rivelavano. Lenny e gli altri avevano percorso quella strada, quella verso il torrente che la nebbia non inglobava. Avevano da mangiare per tutti: i conigli li avevano sequestrati.
Rabbiosamente tirò un cassetto per riporvi di nuovo il contenuto della valigia. Lo aveva fatto quando era arrivato: quel cassetto era vuoto allora, prima che lo riempisse delle sue cose, e vuoto lo aveva lasciato, completamente vuoto, quando aveva tentato di partire. La cartolina, prima, non c’era. Una cartolina in seppia degli anni Trenta. Maurizio la girò: ‘15 agosto 1934. Saluti da Riccione. Mario e Luisa.’ Guardò le firme, le guardò con molta attenzione, poi ripose la cartolina nel cassetto e vi stese sopra le sue camicie.
Erano passati ormai tre giorni e la pioggia si era trasformata in goccioline minute. Maurizio sapeva immaginare il torrente: marrone, con i rami impigliati nei sassi che arrestavano la schiuma.
“Appena finirà di piovere ripristineranno la strada, – diceva l’Uomo Grosso – Capita spesso, sa, di rimanere isolati qui: la pioggia e le frane spesso; ogni tanto la neve. La strada non la vogliono asfaltare… Noi siamo attrezzati, però. Mi dispiace che non si trovi bene da noi…”
“No, no… E’ che…”
“Capisco, sa. Lei ha l’abitudine alla città. In casi come questo, qui è come essere in prigione a scontare chissà che pena.” L’Uomo Grosso gli aveva sorriso ed era restato a guardarlo un po’ più a lungo di quanto a Maurizio non paresse appropriato. Poi si era infilato un impermeabile grigio-verde ed era uscito. Per raggiungere la stalla era passato dove la macchia che non poteva non esserci stata non era stata mostrata.
Il tavolo di Maurizio era di fianco ad una vetrina, non antica: vecchia, però tirata a lucido come usa nel rustico a consumo dei cittadini. I vetri molati racchiudevano stoviglie e, in un ripiano, ninnoli di gusto campagnolo. Quella fotografia nella cornice d’argento prima non c’era; Maurizio ne era quasi certo. Gli sarebbe stato impossibile non vederla, dato che era esattamente all’altezza dei suoi occhi. Un uomo e una donna ritratti in bianco e nero, in abito da matrimonio, si tenevano a braccetto. A inchiostro, con la calligrafia che si studiava a scuola una volta, ‘14 agosto 1934, XIII’.
Smise di piovere, e dopo un paio d’ore arrivò una camionetta dei carabinieri.
“Non abbiamo bisogno di niente,” aveva detto l’Uomo Grosso.
“Torniamo domani,” aveva risposto uno dei due militari.
“Ti dico che non abbiamo bisogno.”
“Ciao, Mario. Ci vediamo domani.” Ed erano ripartiti scivolando sul fango.
Domani sarebbero tornati. Magari Maurizio avrebbe potuto chiedere ai carabinieri di portarlo via. La macchina l’avrebbe lasciata lì e sarebbe tornato a prenderla in tempi migliori. Corse in camera a preparare la valigia.
A cena il cuore gli batteva così forte che non riusciva ad inghiottire. Doveva andarsene. La ragazza andava e veniva solo per lui, e l’Uomo Grosso – Mario – sorrideva con il gomito appoggiato sul tavolo e la testona con pochi capelli neri sostenuta dalla mano stretta a pugno.
“Non mi chiamo Mario, sa: – aveva improvvisamente detto l’Uomo Grosso, facendo trasalire Maurizio, senza muoversi dalla sua posizione – il mio nome è Angelo, come un fratello di mia madre morto appena nato. Mario era il nome di mio padre. – Il cuore di Maurizio si fermò per un attimo. – Qui mi chiamano così.”
Risalì in camera. La valigia era chiusa e stava pronta sul cassettone. Appena fosse arrivata la camionetta, a qualsiasi ora, a qualsiasi costo, ci sarebbe salito sopra e se ne sarebbe andato. Non riusciva a restare tranquillo: si sedeva sul letto, si alzava, apriva la finestra e la richiudeva subito dopo. Schiuse appena la porta. “Ma no, te l’ho detto ieri: – diceva al telefono Mario – non c’è nessun bisogno che veniate.” Maurizio scese le scale di corsa.
“Non viene la camionetta?”
“Ma no. Che bisogno c’è?” aveva sorriso Mario o Angelo o come diavolo si chiamava quell’uomo grosso che non lo lasciava partire.
Maurizio risalì in camera, la bocca serrata e tutti i muscoli tesi.
Decise che avrebbe tenuta tutta la sua roba nella valigia, pronto ad andarsene, a fuggire, alla prima occasione possibile. Pensò di andar via a piedi, di farsi come allora quella strada che lo separava dal paese e dalla fermata della corriera, ma la nebbia fredda che sbarrava la finestra lo dissuase. O forse fu il pensiero di ripercorrere la strada di allora.
Si sedette sul letto e si prese le tempie fra le mani. Tra i piedi si trovò un piccolo lembo di stoffa tricolore che sbucava da sotto il letto. Si chinò e lo raccolse: era un nastro annodato sull’occhiello di una medaglietta. Prese gli occhiali: ‘Patronato pei Figli del Popolo’ su una faccia e ‘1946’ sull’altra.
Quando si prende una decisione, affrettata o ponderata, capricciosa, generosa, cattiva, istintiva, eroica, contro natura, non importa; quando si prende una decisione come quella s’impartisce una direzione imperiosa ad una vita altrui, a più di una vita altrui. Si diventa fabbri di una fortuna che prima di quell’attimo non ci era mai appartenuta. Si sceglie una strada per qualcun altro e poi non ci si cura del cammino. Lenny l’aveva fatto, e prima di lui Maurizio.
Quando il motore della camionetta zittì i tarli, Maurizio restò seduto sul letto. Sulla finestra appannata pesanti gocce lacrimavano, lasciandosi una scia diafana al seguito.
Passò la giornata, passò anche la notte con i tarli, stupidi, a scavare le loro gallerie, a percorrere impietosamente il legno, annientandolo con pazienza infinita. Puoi ucciderne uno, cento, mille, forse, ma dietro quei mille ce ne sono altri mille, lì, ticchettanti, indaffarati, indifferenti alla morte dei mille compagni. Sono loro i padroni.
L’alba, soffocata nella nebbia, cedette all’improvviso, senza avvisaglie, ad un cielo lustro immacolato. Le montagne scintillavano con le sommità intinte di neve, gli alberi fioriti luccicavano di goccioline, i prati, presi d’infilata dal sole basso, offrivano quanto restava della nebbia. Non il soggetto, ma la nitidezza pignola era di Bellotto. Qualsiasi bufera, per interminabile e disperata che possa sembrare, è destinata a finire. Il tempo presente nutre di loto il tempo passato.
Maurizio spalancò la finestra. Il processo se l’era fatto; aveva emesso la sentenza; aveva espiato, soffrendo per purificarsi. Ora anche il sole diceva che poteva bastare, che la pace era fatta. Allora scese le scale e uscì sull’aia che la pioggia aveva lavata. Gli si pararono davanti le montagne, la strada, il torrente tra le due colline rotonde. Si girò verso la porta e vide il portico lastricato di pietra cotta che dava sul fienile. Una volta ci stavano un carretto e un aratro. E una macchia che si allargava. Maurizio capì che non era finita.
“Ho visto dai suoi documenti che lei abita in Via Farini, a due passi dal mio vecchio collegio,” gli disse Mario sedendosi accanto a lui a pranzo finito. Quel sorriso da oste che la sa lunga…
“Sì, in Via Farini…”
“Nel ’45, in un colpo solo, rimasi senza genitori e mio zio mi mandò in collegio: ci chiamavano i ‘Patronatini’. Fece studiare solo me, mio zio. Per quel poco che ho studiato, si capisce, – aggiunse sorridendo. – Il sabato sera tornavo a casa e la domenica pomeriggio riprendevo la corriera che mi riportava in città.” Lo guardava negli occhi e sorrideva. Sorrideva sempre.
“La strada…?”
“Sì, è praticabile.”
Maurizio avrebbe potuto andarsene da lì.
“Mio zio era più giovane di mio padre, – continuò Mario senza accettare il cambiamento di discorso – Si era sposato dopo di lui e in cinque anni sua moglie gli aveva sfornato quattro figli. L’ultimo, il quinto, morì con lei. C’era tanta neve. C’era la guerra. Io me lo ricordo bene. Lei stava male e la levatrice non riuscì ad arrivare in tempo. Mia madre tentò di aiutarla ma, emotiva com’era, non combinò gran che.” Sorrise ancora.
Si può morire perché c’è la neve. Se non ci fosse stata la neve, chissà, quella donna, la zia, avrebbe fatto un sesto, forse un settimo figlio. Il bambino morto sarebbe diventato chi può immaginare che? Avrebbe fatto del bene. Oppure del male. Oppure né l’uno né l’altro, come la maggior parte degli uomini. Sì, come la maggior parte degli uomini, i fortunati, avrebbe attraversato il tempo che gli era toccato in sorte senza lasciare traccia. E se la donna, l’altra, non fosse stata così emotiva, forse avrebbe salvato madre e figlio. Quasi di certo sé stessa.
“A mio padre la politica non interessava. Invece mio zio era un fascista. O così diceva lui. Oggi fa un po’ ridere vedere le sue foto in camicia nera. Era un buon uomo, sa. Fu anche podestà, il più giovane della Provincia, gli piaceva sottolineare, e qualcosa di buono lo fece. L’acquedotto lo portò lui. Anche l’elettricità. E’ ancora vivo, sa. Ma qui non ci vuole venire a stare… Qui, in realtà, politica non se ne faceva. C’era da lavorare sodo e basta.”
Maurizio ci aveva creduto. Aveva creduto di crederci, magari come lo zio. Sullo stesso fiume ma sulla riva opposta. Anche ora, in quella prospettiva temporale di cui non era più padrone, era convinto che la scelta fosse stata giusta. Dal punto di vista storico, da quello filosofico, non aveva sbagliato. Anche i libri erano d’accordo. Non importa se ben poco, a guardare fino in fondo, era cambiato e non sarebbe stato facile attribuire un’utilità certamente obiettiva a tutto quel terremoto. E’ inutile illudersi. E’ inutile costruire ad ogni generazione, con immutabile ingenuità, città ideali: l’Uomo resta quello che è, indipendentemente dalla camicia che indossa. Forse non è nemmeno responsabile della natura che si trascina appresso. Almeno non del tutto. Forse è la sua intelligenza a tradirlo: la sua dialettica, così sottile che è capace d’ingannarlo, che lo convince della giustezza di qualsiasi pensiero, di qualsiasi opinione, di qualsiasi decisione, di ogni cosa e del suo contrario. Gli orrori dell’Inquisizione, le guerre per un posto al sole, la giustizia disuguale, la menzogna: non esiste nulla che non si sappia giustificare; nulla che non si riesca a santificare. E non sono solo quegli uomini che gridano forte o che cantilenano in coro ad assordare le coscienze, ad anestetizzarle, e a corroborarsi l’un l’altro nella convinzione; è l’Uomo da solo che, dentro quell’universo inesplorato e sorprendente che è il suo cervello, riplasma la morale a suo uso. Non è l’intelligenza che fa difetto: è la forza. La forza di chiudere gli occhi e di processarsi tutti i giorni senza privilegi: ogni universo deve pesare esattamente come quello del suo prossimo. La forza di essere giudici, imputati e parte lesa insieme. A Maurizio venne in mente che quello era, né più né meno, l’esame di coscienza di cui gli parlava il parroco. Finché si era ricordato della cosa, l’aveva sempre trovata ridicolmente infantile. Quel vecchio prete rimbecillito con la testa che scuoteva di continuo come a negare ogni sua affermazione era una macchietta. Ma ora… Chissà se il poveretto si rendeva conto appieno dell’enormità di quanto andava predicando, o se quella filastrocca che ripeteva da sempre e che, fuori di dubbio, aveva sentito ripetere da altri mille e mille volte lo aveva rincretinito così tanto da impedirgli di apprezzare la grandezza eroica che quella pratica impone. L’esame di coscienza; ‘Non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te’: una pratica e una legge così squisitamente umane da essere fuori portata per qualsiasi uomo.
“…suppongo non voglia più partire…” Maurizio sentì che l’Uomo Grosso che tanto somigliava a Mario stava dicendo.
“No… no…”
“Con questo sole…”
“Già, con questo sole…”
Non fu una sorpresa trovare la fotografia di Mario nel cassettino della specchiera sul comò. Sotto la croce e il nome, le date: ‘1° gennaio 1908 – 16 aprile 1945’. Se nell’inverno del 1908 ci fosse stata abbastanza neve…
E non fu una sorpresa scoprire, appesa in fondo al corridoio, la fotografia di due uomini giovani, estremamente somiglianti tra loro, che tenevano le loro mani tozze sulle corna di un bue infiocchettato.
Il tempo era un concetto inafferrabile: oggi, ieri, mille anni fa… Non c’era significato.
Si sentiva: di lì a poco la guerra sarebbe finita. Bisognava sbrigarsi: come poi avrebbero detto i libri, i destini si stavano inesorabilmente compiendo. Con esasperante lentezza gli Alleati risalivano verso Nord e i Tedeschi, da tempo alle corde, avevano modo di ritirarsi e di far male ancora. I Partigiani preparavano come potevano la strada all’esercito più imponente della storia.
Quando Maurizio era scappato dalla casa in cui erano sfollati, suo padre, piccolo funzionario comunale, ne fu atterrito. Era la fine dell’inverno, tutto intorno le macerie s’imbevevano di pioggia e la guerra era perduta. Il Duce aveva sbagliato; solo la vita si poteva ancora salvare. E ora anche il ragazzo passava dall’altra parte. Andava a rischiare la pelle chissà dove, chissà per chi.
“Prenditi il nome che ti pare,” gli aveva detto il Capitano.
“Lenny. Può andare bene?” Ma il Capitano si era già voltato.
Con un gruppo di altri ragazzi raggiunse le colline. Ogni tanto facevano saltare un tratto di strada, un ponte, un traliccio. Nessuno chiedeva il perché: erano gli ordini. Dormivano nei fienili, qualche notte in uno, qualche notte in un altro, stando attenti a non rovesciare sull’erba secca la lampada a petrolio. Facevano i turni di guardia scaldandosi con le sigarette. Intorno la neve marciva scoprendo il fango: tanto fango.
Ermes aveva ucciso un tedesco. Era partigiano da oltre un anno e in autunno aveva ucciso un tedesco. Era il capo riconosciuto del gruppo. Lui parlava con il Capitano.
Più veloce degli Alleati arrivò la primavera con le sue piogge improvvise, con i suoi cieli senza macchie, con il suo vento e con le sue nuvole sfilacciate. Le montagne si scoprivano verdi e grigie.
Ogni giorno che passava la vittoria era più sicura. L’Italia sarebbe stata un paese ideale: niente più ingiustizie, libertà per tutti. Mai più guerre, anche se la guerra era esaltante. Maurizio portava il suo contributo alla causa giusta.
Radio Londra mandava i messaggi in chiaro e in codice. Ormai le colonne alleate erano vicinissime. Vincere non bastava: bisognava stravincere; bisognava offrire loro un’Italia purgata di ogni nemico; far vedere loro di che pasta si era fatti.
Allora andarono a cercare il Podestà. Alla Colombara. Abitava alla Colombara, avevano detto in paese.
Circondarono l’aia e in quattro avanzarono verso la casa. Tutto intorno era deserto. Le porte e le finestre erano chiuse.
Lenny guardò i compagni e bussò. Ermes lo spinse via e colpì la porta con un calcio, poi con un altro, poi andarono a prendere il carretto sotto il portico della stalla. Lo usarono come un ariete e dopo tre o quattro urti i cardini cedettero. Nello stanzone c’era un uomo in piedi, apparentemente solo e forse disarmato.
“Sei tu il Podestà?” gli gridò in faccia Ermes.
L’uomo, grosso, con pochi capelli neri non rispose. Ermes lo colpì con un pugno.
“Sei tu il Podestà?” gridò ancora più forte Ermes con la saliva che gli colava sul mento.
L’uomo si passò una mano sulla bocca insanguinata.
“Fuori! Qui è buio. Portiamolo fuori!”
Lo portarono dove avevano preso il carretto.
Lo colpirono a turno, anche Lenny, ma quell’uomo grosso insanguinato, che uno per volta li avrebbe potuti atterrare con un solo schiaffo di quelle mani tozze e ruvide, non fece mai sentire la sua voce. Nemmeno quando Ermes estrasse la pistola e questa non voleva saperne di sparare. Nemmeno quando Lenny spalancò gli occhi pazzi di terrore e ubriachi di sangue e gli sparò nel cuore. Era già morto quando tutti si voltarono di scatto al grido di una donna che usciva correndo dalla casa. “E’ Mario, lasciatelo stare!” urlava. Lenny sparò di nuovo e con sua sorpresa la donna crollò in mezzo all’aia come un fantoccio di stracci. Aveva sparato e non se n’era accorto.
Una macchia rossa si allargava sul pavimento di mattoni sotto il portico. La donna, senza più anima, in mezzo all’aia copriva il suo sangue. O forse la terra, pudicamente, lo assorbiva per non farlo vedere.
“Io ero nel fienile quando uccisero mio padre,” gli sembrò che gli dicesse Angelo.


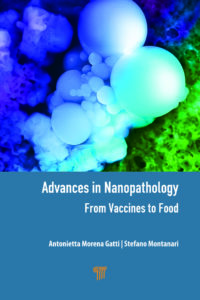

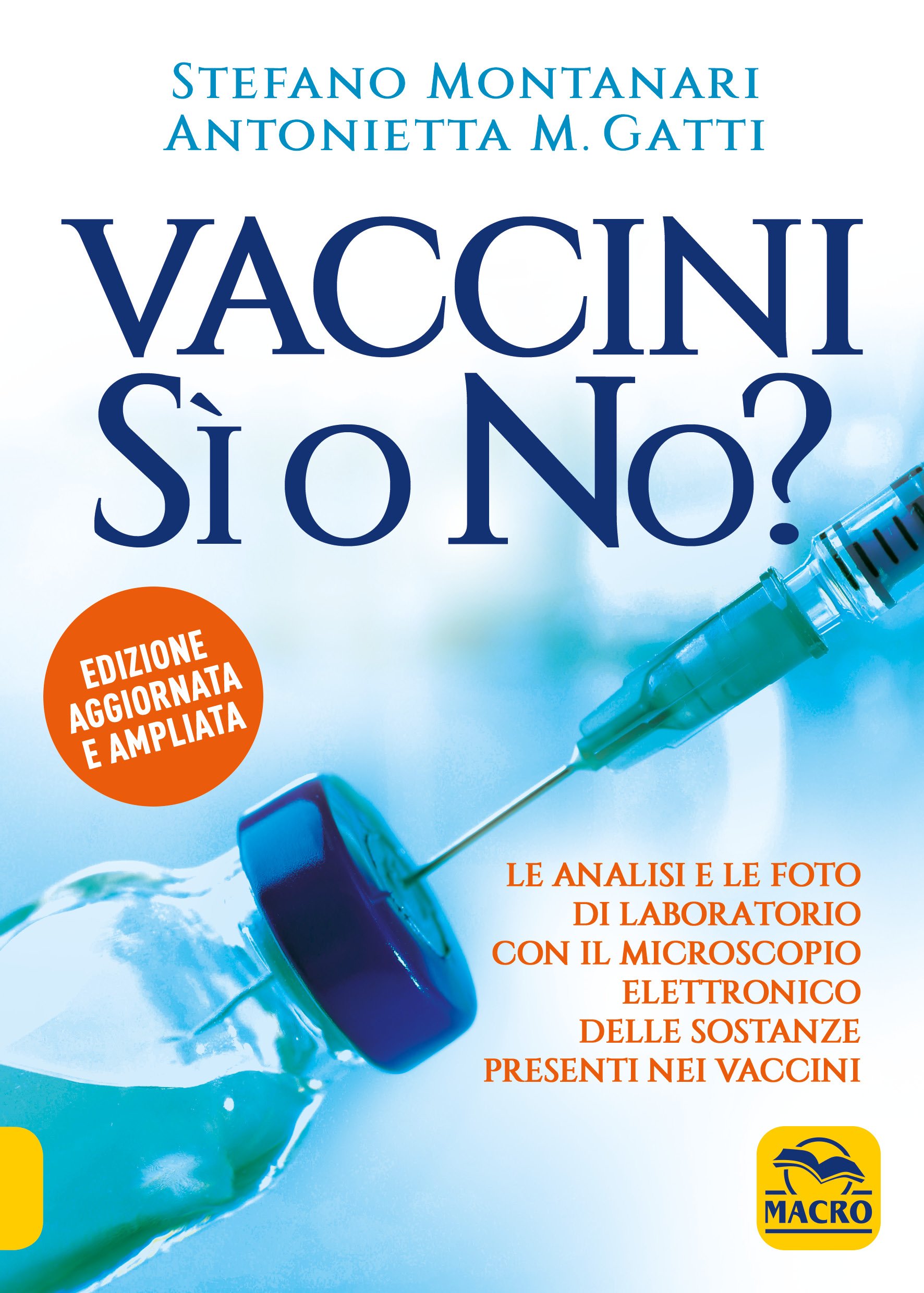
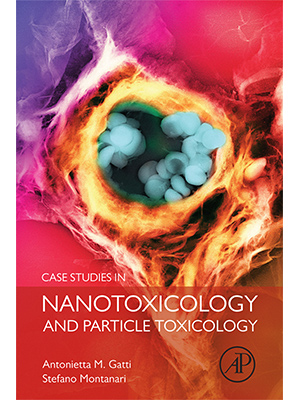




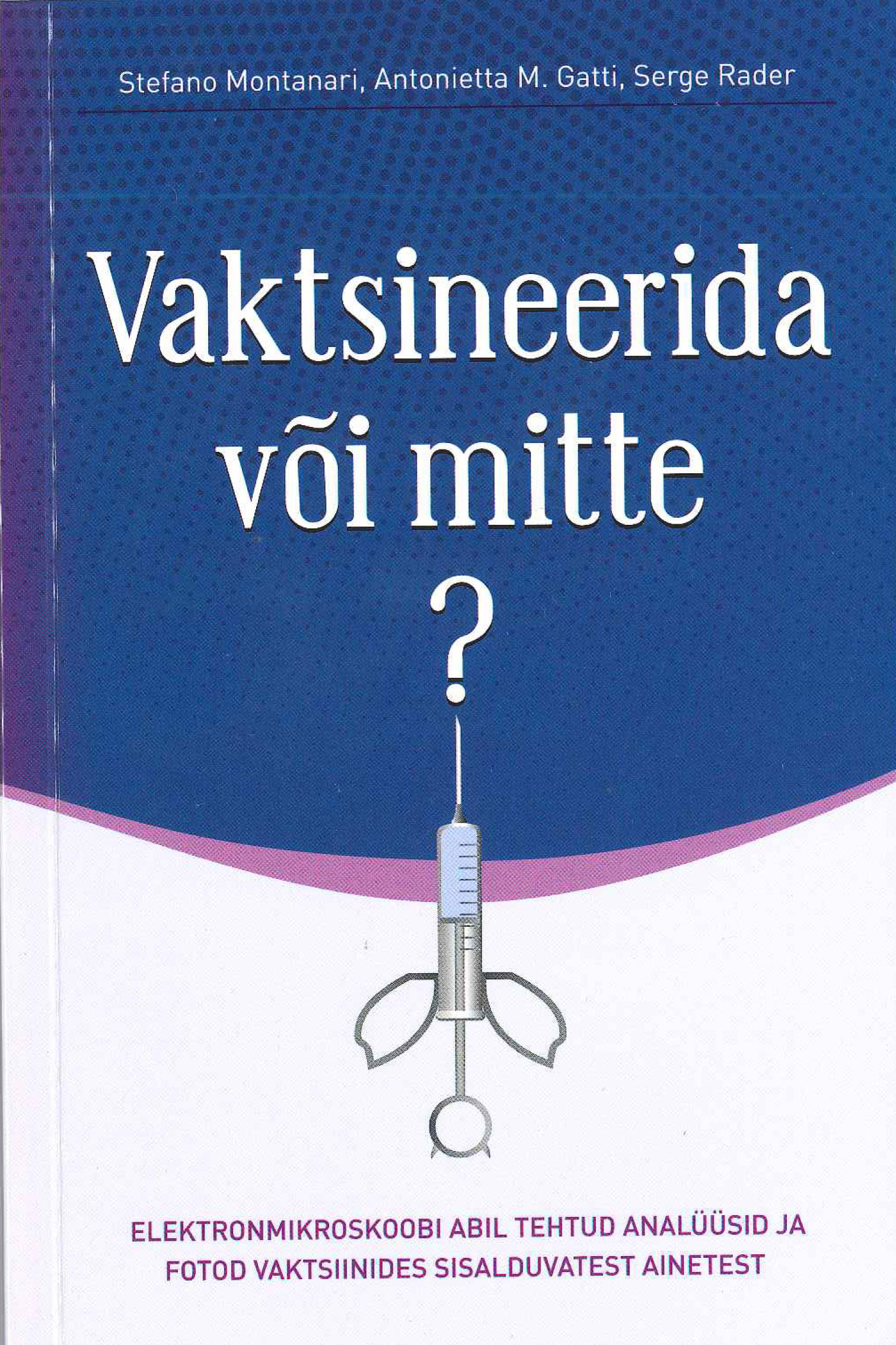
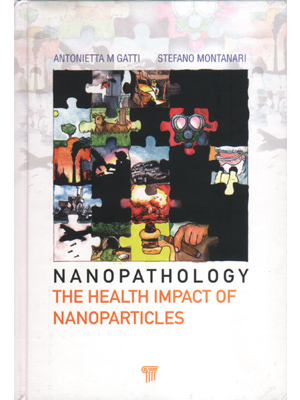




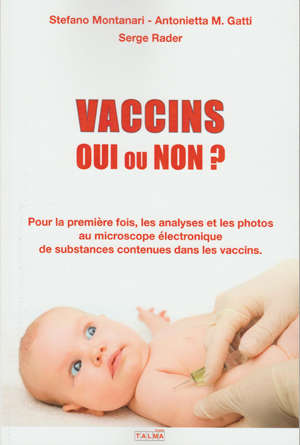


Egr. Dr. Montanari
“As of 19 March 2020, COVID-19 is no longer considered to be a high consequence infectious diseases (HCID) in the UK”
https://www.gov.uk/guidance/high-consequence-infectious-diseases-hcid#status-of-covid-19
No comment … solo : “Explain this!”
Comunque, dopo il devastante abbassamento delle ns difese immunitarie conseguente all’aver visto nei giorni scorsi sfilate di bare su mezzi militari, ed ora persone che rimaste senza soldi danno l’assalto ai supermercati, ritengo sia giusto e salutare farci quattro risate con questo brevissimo ma esilarante micro-documentario “The First Swedes”:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=54&v=MUUxOHfpG_4&feature=emb_logo
A proposito della vitamina D, è incredibile (ma mica poi tanto, considerato come va il baraccone della sanità) quello che afferma il dott. Orlandini in questo “rocambolesco” video. https://www.facebook.com/StudioMedicoOrlandini/videos/615756862487446/ 1100 studi su PubMed dimostrano che la somministrazione della vitamina D fa abbassare i livelli di interleuchina 6, ovvero di “quel fattore che in questo momento sta determinando le complicanze polmonari per ciò che riguarda l’infezione da coronavirus”. Testo dal video… «(…) La polmonite interstiziale che avviene nei pazienti affetti da infezione da coronavirus non è determinata da presenza del virus direttamente nei polmoni, ma è legata, purtroppo, ad una reazione… Leggi il resto »
Massimo Mazzucco nel suo blog per quanto concerne l’intervista appena rilasciata scrive…
«A proposito del caso Montanari, segnalo una cosa curiosa. Per oggi avevo tre interviste programmate, per tre testate online (volevano intervistarmi sulla questione del pipistrello). Ma dopo che ho pubblicato l’intervista a Montanari, stamattina, sono state tutte cancellate, con scuse varie.
Forse è solo una coincidenza».
https://www.luogocomune.net/21-medicina-salute/5480-coronavirus-intervista-a-stefano-montanari#comment-164200
La paura fa 90 ed è esattamente quello che volevano.
RISPOSTA a Dantes – La gente adora avere paura.
Facciamo un po’ di pubblicità…
Coronavirus: a contro.tv Massimo Mazzucco intervista il dott. Stefano Montanari
https://youtu.be/qjbHh75tPms
Mi permetto di fare una considerazione. Qualcosa è cambiato (di certo in meglio) nel blog, e credo che ce ne siamo accorti tutti. Sarà stato probabilmente lo shock e la conseguente reazione a catena dovuta alle misure restrittive intraprese dal governo iatrocratico. La classica zappata sui piedi: più si restringono i diritti umani, più si configura una deflagrazione imminente; più si cerca di non far sapere, e sempre più gente si orienta verso canali alternativi all’informazione mainstream; più si cerca di occultare e più la verità viene a galla. Ad ogni modo, ora le visite al blog sembrano essersi, come… Leggi il resto »